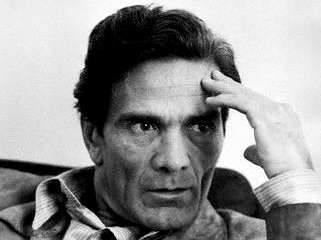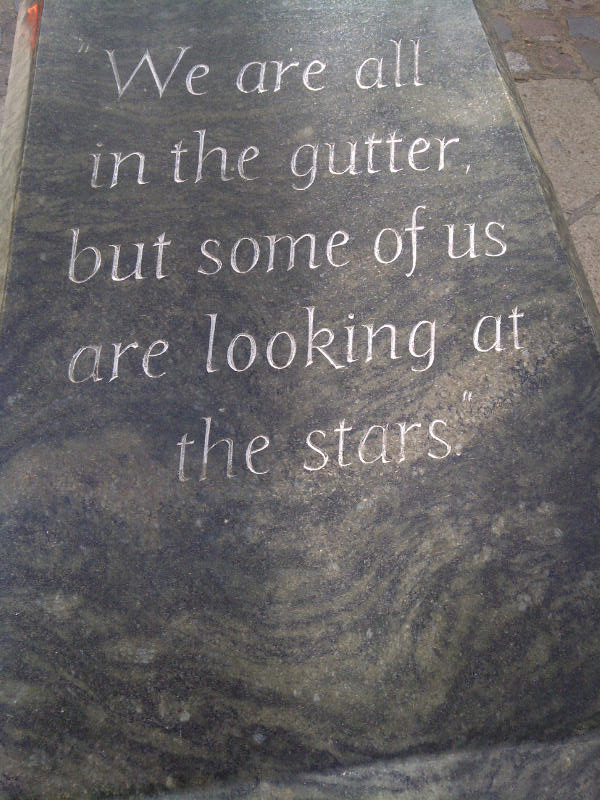La corona di Ciccia non era d’oro. Era fatta di capelli. Non aveva pietre preziose incastonate, ma tanti ferretti. Quelli che tenevano arrotolata sulla sua testa una lunga treccia, d’inverno nascosta sotto un foulard prima a fiori, poi nero.
Da bambina Ciccia non era stata una principessa, anche se era riuscita a completare la scuola elementare. Una rarità, in un paesino dell’Aspromonte negli anni ’20 del secolo scorso. Tempi in cui si diventava presto donne, soprattutto se si avevano due sorelle e un fratello più piccoli. A 12 anni si era già mamme. Non erano tempi di amori da feuilleton. Se uno zio acquisito, Micu, rimaneva prematuramente vedovo perché la moglie era morta di parto, era quasi naturale che toccasse alla nipote più grande allevare, assieme ai fratelli, i due cuginetti. Non di rado, capitava di andare in sposa allo zio. Quattordici anni di differenza non sono pochi, ma questa era l’ultima delle preoccupazioni. I problemi si risolvevano in famiglia.
Quando iniziava la primavera, Micu si trasferiva sull’Aspromonte, mesi e mesi senza tornare a casa, giorni interi a tagliare legna e, di notte, a sorvegliare la carbonaia. Poi la guerra nel teatro libico, la prigionia e il rientro a casa. Un carbonaio analfabeta, spedito dal Duce a difendere la Quarta Sponda, doveva per forza diventare comunista. E così fu per Micu, tessera del Pci nel portafogli e sul comodino i ritratti di Stalin e Togliatti, accanto al rosario e al libro di preghiere della moglie.
Il mondo di Ciccia era un cucinino, un gabinetto e due stanze. Per qualche tempo, una. Da dividere con mamma, marito, uno dei due cugini e due figli (un maschio e una femmina), per il periodo in cui nell’altra camera si accampò un parente con tutta la famiglia, una sistemazione “provvisoria” durata diversi anni. Sempre meglio dei molti che, ancora negli anni ’60, vivevano nelle baracche in legno del dopo terremoto, monolocali affollatissimi privi di acqua, servizi igienici, corrente elettrica. Attaccato al suo mondo c’era l’Eden, raggiungibile varcando l’uscita sul retro. Un piccolissimo ma ricco giardino, curato con amore e applicazione: rose bianche e rosse, calle, fior d’angelo, biancospino, gladioli, begonie, garofani, tulipani, dalie, un cespuglio di margherite, un albero di camelie, due di mele del paradiso, un mandarino, un arancio.
Nel suo mondo c’erano soprattutto due figli da accudire, in particolare la piccola di casa, alla quale portava ogni mattina una tazza di latte e fette di pane nel letto. Ai piedi, a mo’ di borsa dell’acqua calda, un mattone riscaldato nel braciere; in caso di mal di gola, anche un calzino pieno di cenere viva da tenere arrotolato al collo come una sciarpa.
La stessa attenzione usata più avanti nei confronti dei nipoti, le cui date di nascita teneva appuntate su un quaderno di prima elementare: 10.000 lire al festeggiato, 5.000 agli altri. A Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, uguale trattamento per tutti.
A cavallo degli anni ’80, si stava bene da Ciccia. Stretti stretti, il calore aumentava. La porta era sempre aperta e i bambini entravano di corsa dal cortile per bere, accaldatissimi e sporchi. Si faceva merenda con pane, sale e olio. D’estate, l’orzata. Dolcissima, nel bicchiere che portava stampate sul vetro macchinine d’epoca. L’idrolitina del cavalier Gazzoni, no: quella la beveva soltanto lei. Per i gelati bastava andare in uno dei due alimentari della ruga: i putijari segnavano nella libretta, poi passava Ciccia. Si dormiva nello stesso letto e, appena svegli, la colazione era baldoria, con la scatola dei biscotti Doria da tre chilogrammi al centro della tavola e tutti attorno cinque piccole pesti pronte a sfidare enormi tazze arancione. La domenica tutti a messa: al momento dell’offerta, nella mano di ogni bambino scivolava una moneta da deporre nel cestino. Subito dopo, la cucina sprigionava l’odore del sugo con le polpette che avrebbe condito i maccheroni fatti in casa e stesi sul letto matrimoniale, sopra un lenzuolo bianchissimo. Ed era festa.