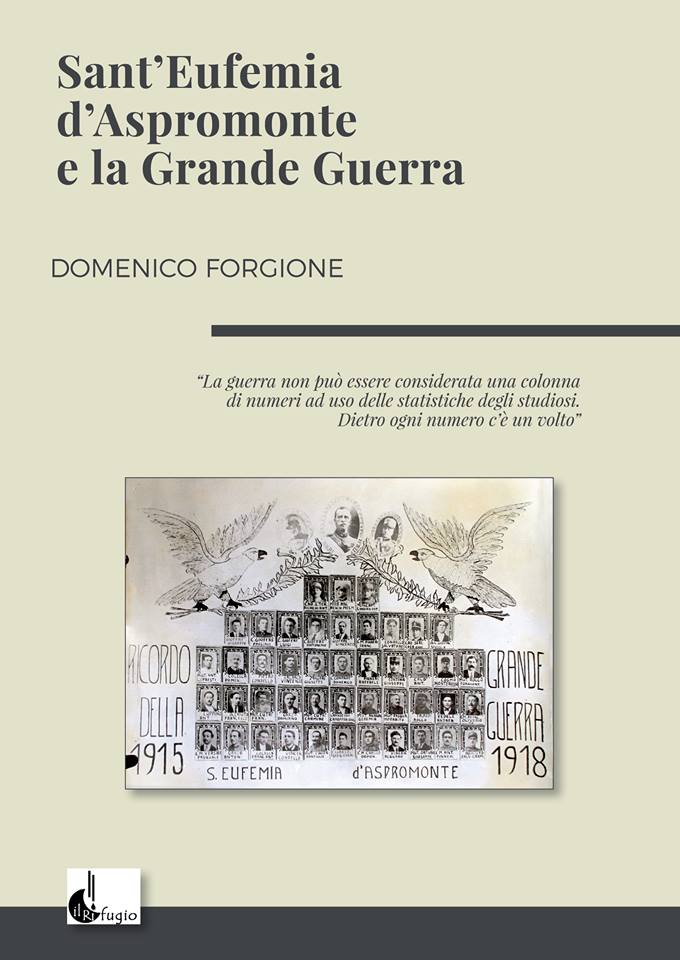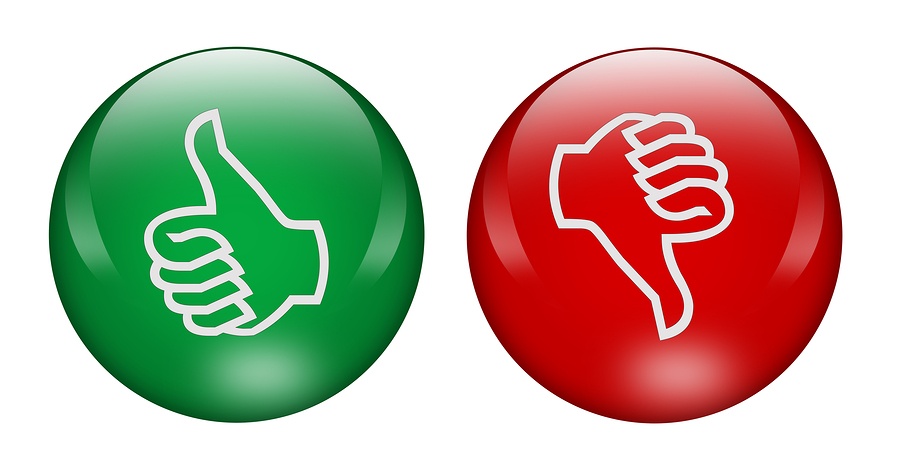Molti pensano che Nino Altavilla sia mio zio, insomma che lui o sua moglie Eufemia siano fratello o sorella di uno dei miei genitori. Non è così e la storia che lega le nostre due famiglie è la testimonianza di come a volte i rapporti di amicizia siano più forti, più profondi di quelli di sangue.
Vorrei scrivere qualcosa di bello, oggi che Nino compie settant’anni, anche se so di correre il rischio di apparire agiografico o retorico. Due aggettivi che non si conciliano con la sua personalità riservata. Non apprezzerebbe. Probabilmente un po’ di fastidio lo proverà anche se verrà a conoscenza di queste mie parole: i festeggiamenti “in suo onore” non li ha mai graditi. Comunque capirà e mi perdonerà.
Come faccio a mettere da parte sentimenti che riempiono la mia vita dal 1977, da quando con i miei genitori e fratelli tornammo dall’Australia? Ce ne innamorammo allora, con Luigi e Mario. Abbiamo giocato sulle sue ginocchia, goduto della sua simpatia e del suo affetto smisurato, della sua naturale capacità di farsi amare dai bambini: nei miei nipoti oggi rivedo noi piccoli, che stravedevamo per lui.
Nella casa dei suoi genitori, nel cortile dove anch’io sono cresciuto, ho ascoltato le storie della dura alba del Novecento. Ancora, i racconti della sua infanzia, ricordi di bambini sgualciti del secondo dopoguerra che avevano sempre mondi nuovi da scoprire e avventure da vivere in spazi sconfinati. Spericolati o forse soltanto più liberi e geniali con i loro giochi di strada, la caccia ai nidi e alle lucertole, gli orti razziati, i bagni nelle fiumare. I mille mestieri dai “mastri” più disparati. Le avventure ardimentose con mio padre (la foto sotto li ritrae in piazza municipio) e con i giovani della sua generazione, quasi tutti poi emigrati. Come Nino, che all’inizio degli anni Settanta va a finire a Cuba: e mi sembra un eroe della Frontiera in sella al suo cavallo, allacciati agli stivali gli speroni in seguito regalati a mio fratello Luigi.
Ma non voglio raccontare Nino, né la forza di questi suoi settant’anni. Mi ha insegnato l’amicizia vera, quella che non si lascia sfiorare dal dubbio se sia il caso di lanciarsi contro il fuoco; quella fatta di parole di verità e di giustizia, sempre. Non si diventa casualmente punto di riferimento per fratelli, sorelle, nipoti, amici: occorrono saggezza, generosità, rispetto dell’opinione altrui, lealtà.
Un uomo “preciso” che pretende serietà e che in ogni circostanza sa pesare le parole, trovare i modi giusti, dare i consigli più opportuni: questo è Nino, il mio secondo padre.