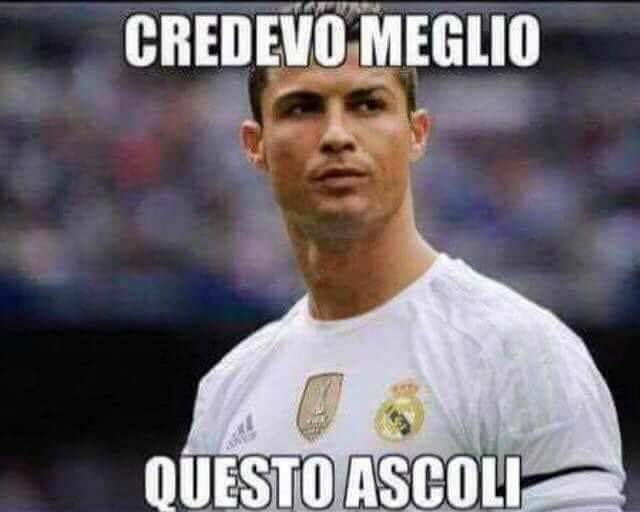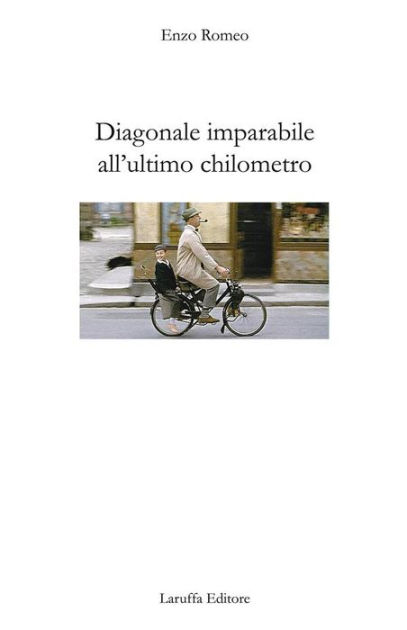Dai, adesso diamoci una calmatina. Bel gesto l’appaluso tributato dai tifosi juventini a riconoscimento della bellezza del gol di Cristiano Ronaldo. Un atteggiamento che rende onore ai supporters bianconeri, da apprezzare e incoraggiare affinché diventi la regola sugli spalti. Ma anche nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, nei rapporti interpersonali. Basta invidie, basta rancori: viva la sportività!
La cartolina turistica però risparmiatecela. Non è credibile perché la storia dice altro.
Penso che il contesto internazionale incoraggi questo genere di reazioni. Siamo italiani, a noi interessa soltanto che l’erba del nostro vicino sia più secca della nostra. I giardini più lontani riusciamo ad apprezzarli senza eccessivi rodimenti di fegato. Se si vuole, c’entra un po’ anche l’attitudine provincialotta a rivelarsi forti e arroganti con i deboli, deboli e dimessi con i forti.
Il Real Madrid gioca un altro campionato, in fondo non viene considerato secondo i dettami che impone la categoria del nemico. Per questo riusciamo ad essere buoni e obiettivi, qualità che si manifestano raramente quando l’avversario è, appunto, il nostro vicino di casa con il suo giardino più curato e fiorito del nostro.
Sarebbe bello che questo encomiabile sforzo di obiettività emergesse anche quando l’avversario è un concorrente diretto per la vittoria nel campionato italiano. Che le “sviste” arbitrali a favore non venissero rivendicate quasi con orgoglio, con il ghigno sadico e cinico di chi gode nel ribadire il concetto filosofico cardine dello stile Juve: «Conta solo vincere».
Non ricordo applausi per le prodezze di Maradona o di Luis Nazario de Lima Ronaldo, tanto per citare due fenomeni probabilmente antipatici perché curavano giardini confinanti con quello bianconero.
Milano chiama, Napoli risponde
La trasmissione sportiva «90° Minuto» fu fenomeno di costume negli anni Settanta e Ottanta. Un rito collettivo celebrato da milioni e milioni di telespettatori sintonizzati ogni domenica pomeriggio su RaiUno per vedere, dopo la loro conclusione, le immagini delle partite del campionato disputate tutte, rigorosamente, allo stesso orario. Rito officiato fino alla sua morte (1990) da Paolo Valenti, un signore d’altri tempi: «Amici sportivi, buon pomeriggio», il suo consueto incipit.
Collegamenti da tutti i campi di serie A (16 squadre, la vittoria valeva due punti), big match della serie B e, in chiusura di trasmissione, la lettura dei risultati delle partite di serie C.
Ripenso con nostalgia a quegli anni, all’epica delle partite ascoltate grazie a «Tutto il calcio minuto per minuto». Tutti attorno alla radio, al bar, con in mano le schedine per aggiornare negli spazi bianchi delle matrici i risultati mano a mano che qualche squadra segnava. I più grandi sulle macchine: davanti alla pineta, parcheggiate accanto ai marciapiedi, al municipio o al campo sportivo (magari mentre giocava l’Eufemiese). Poi l’attesa di «90° Minuto», difficile da spiegare all’epoca delle pay-tv e dei contenuti video su internet in tempo reale.
Abbiamo amato Paolo Valenti come uno zio e ci siamo affezionati ai corrispondenti dai vari campi come se fossero parenti in visita, preceduti dal jingle indimenticabile della sigla della trasmissione. Personaggi semplici, alcuni all’apparenza strampalati ma in realtà dotati di cultura, professionalità e attaccamento alla Rai. Da Firenze Marcello Giannini, che era stato la “voce” dell’alluvione del 1966; da Ascoli Tonino Carino con le sue giacche assurde; Giorgio Bubba da Genova e Gianni Vasino da Milano, dopo la morte del grandissimo Beppe Viola; Cesare Castellotti con le sue cravatte granata da Torino; da Roma un giovane Giampiero Galeazzi; Riccardo Cucchi da Campobasso e Lamberto Sposini da Perugia; Emanuele Giacoia da Catanzaro e Puccio Corona da Messina.
E poi Luigi Necco, il più simpatico di tutti con quel suo faccione, gli occhiali spessi e i tifosi del San Paolo che finivano sistematicamente per travolgerlo. Raccontò i trionfi del Napoli del Pibe de Oro («San Gennaro perdona, Maradona no»), ma anche le salvezze dell’Avellino di Barbadillo e Diaz, di Juary e Dirceu. Forse il primo a fare il gesto della “manita”, la sua ironia garbata e il suo sorriso («Milano chiama, Napoli risponde», ai tempi del testa a testa con il Milan di Arrigo Sacchi) in fondo ci ricordavano che il calcio è un gioco. Un bel gioco però: «Nella mia carriera ho scritto un po’ di tutto, dalla malavita all’archeologia, però niente è stato più bello del calcio».
*Luigi Necco fu giornalista di cronaca giudiziaria (per il suo lavoro fu gambizzato dalla camorra) e grande esperto di archeologia: suo il ritrovamento del “tesoro di Troia” scomparso alla fine della seconda guerra mondiale. In suo omaggio, Rai Cultura stasera alle 23.00 e Rai Storia domani alle 18.00 proporranno lo Speciale “Mesopotamia”, nel quale il giornalista racconta il tragico destino dei tesori della Mesopotamia, distrutti dall’Isis.
L’allenatore delle notti magiche
C’è stato un tempo in cui il mio personale calendario procedeva a intervalli regolari di quattro anni, un tempo scandito dall’appuntamento con i mondiali di calcio. Quello del 1990 è stato il mio ultimo mondiale da minorenne. Andavo per i diciassette ed ero un ragazzo tutto casa, scuola e calcio. Finivamo di allenarci e scendevamo in piazza per giocare ancora a pallone (che a volte era una pallina o una lattina schiacciata), o in pineta, per le strade, ovunque. Qualche anno prima, categoria esordienti, pur di disputare la partita il giorno dopo un’abbondante nevicata, tra ragazzini facemmo una colletta per comprare sale grosso da spargere sul campo di prima mattina. Ne uscì fuori un incontro epico in un pantano che quello famigerato di Perugia in confronto è una barzelletta. Ricordo con tenerezza quella passione smisurata, ora che qualche capello bianco e un calcio completamente cambiato da quello ancora romantico della mia giovinezza mi fanno seguire questo sport con minore passione. Ma il calcio per me sarà sempre una vecchia fidanzata che mi ha fatto sognare e che mi ha trasmesso emozioni fortissime, sia sul rettangolo di gioco che con l’orecchio attaccato alla radiolina o seduto davanti allo schermo della televisione.
Il 1990 è stato l’anno della mia prima, fortissima, delusione calcistica. Sì, c’erano già state le due eliminazioni dell’Inter in Coppa Uefa contro il Real Madrid (quella della biglia lanciata dagli spalti che colpì Bergomi e l’altra ai supplementari), ma un mondiale è un mondiale: qualcosa di indescrivibile per tutto ciò che può provare un tifoso in novanta minuti di pura trance agonistica. Nel 1982 avevo già vinto un mondiale, insomma a nove anni vantavo già un palmares di tutto rispetto. Quello del 1986 aveva un destino segnato, lo capimmo da subito. Era una squadra di reduci che si erano coperti abbondantemente di gloria, una sorta di ringraziamento finale che Bearzot aveva voluto tributare agli eroi del Bernabeu: ma il destino di quella squadra era segnato, per cui la delusione non fu cocente.
Nel 1990 fu diverso. Mondiali giocati in casa e una nazione intera che sembrava di vivere dentro una favola, quella delle “notti magiche” cantate da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, degli ormoni giovanili impazziti per le gambe di Alba Parietti, arrampicata con le sue provocanti minigonne sullo sgabello dal quale conduceva una trasmissione sportiva.
Una nazionale figlia di Azeglio Vicini, tecnico federale a lungo selezionatore dell’Under 21, che l’aveva plasmata a sua immagine e somiglianza. Un esercito di fedelissimi che macinava gioco e risultati con la sicurezza di chi è consapevole di essere il più forte. Difesa granitica con Bergomi, Ferri, Baresi e il giovane Maldini, l’astro nascente Baggio, la fantasia di Donadoni e la forza fisica di Berti e Vialli. E poi lui: Totò Schillaci. I suoi occhi spiritati sembravano usciti da una favola bella, fatta di sacrifici, fame e tanta gavetta. In quell’estate del 1990 tutti gli dei del mondo si erano messi d’accordo, ogni volta che Totò toccava palla faceva gol. A ogni triplice fischio, tutti nelle strade per sfilare, protagonisti anche noi di un sogno dal quale non avremmo mai voluto svegliarci.
E invece. L’uscita sciagurata di Zenga, allora il più forte portiere del mondo, fu una secchiata d’acqua gelida. Uscimmo dal mondiale in semifinale, senza perdere una partita. La mia fu un’amarezza doppia, perché Zenga era l’idolo dell’Inter dei record. Un doppio tradimento.
Salì sul tetto del Bar Mario, allora nei locali dell’ex cinema di via Carusa. Il ferro al quale era attaccata la bandiera della nazionale è ancora piegato: e furono lacrime amare, lacrime di rabbia, lacrime che solo per amore si possono versare.
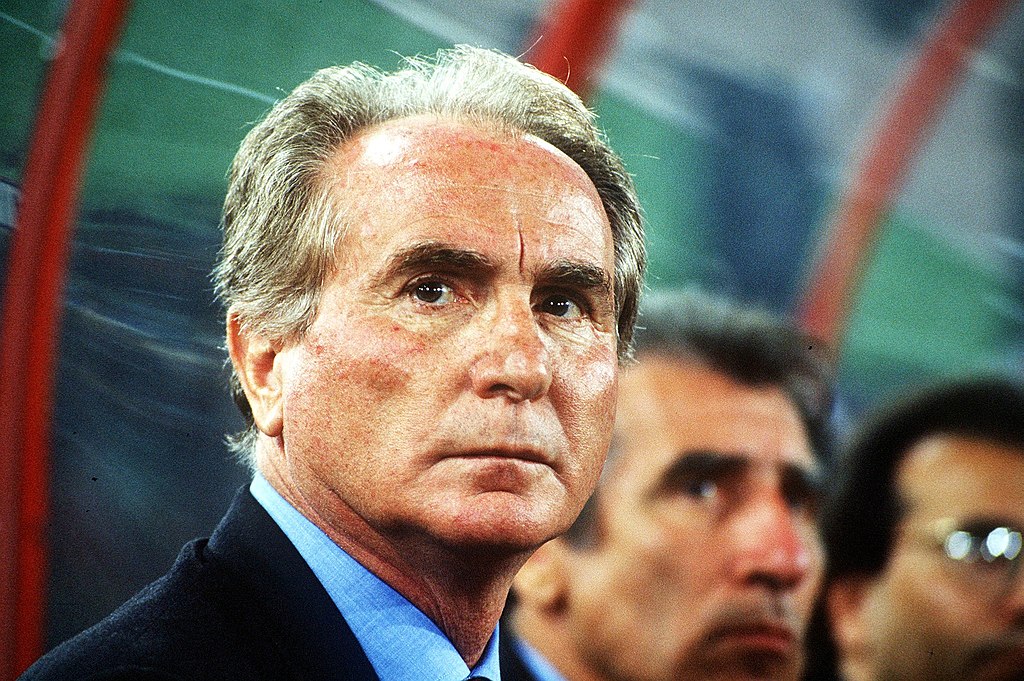
Le buone notizie del Corriere: Vanni Oddera e la mototerapia
Confesso la mia ignoranza: non sapevo chi fosse Vanni Oddera. L’ho scoperto stamattina leggendo «Buone Notizie. L’impresa del bene», l’inserto settimanale del Corriere della Sera che ogni martedì “dà voce alle buone notizie” proponendo le esperienze positive del Terzo settore, del volontariato, dell’impresa sociale.
Ho letto tre volte l’articolo di Fausta Chiesa (La sfida del centauro: «Vi porto tutti in moto»), poi sono andato a cercare altre informazioni su questa storia bellissima, commovente, entusiasmante, che un mese fa il suo protagonista ha anche raccontato in un libro: Il grande salto. Ovvero come ho capito che l’amore per gli altri rende felici (Ponte alle Grazie, 2017).
Di grandi salti Vanni Oddera è un grande specialista, essendo campione di motocross e freestyler di fama mondiale. Il “grande salto” del libro non è però una delle sue consuete e spericolate evoluzioni. Il centauro di Pontinvrea (piccolissimo paese dell’entroterra savonese) lo realizza nel 2009, dopo un incontro casuale con un “mezzo uomo” a Mosca, dove si trova per un’esibizione: «Mi preparo e mi metto in tasca un po’ di banconote, pronto a godermi una mega festa. Prendo un taxi e appena salgo sento una puzza orrenda. Infastidito, mi sporgo in avanti e vedo che il taxista non ha le gambe. Guida con l’aiuto di aggeggi sul volante ed è difficile per lui scendere per fare la pipì, ma anziché fare l’elemosina lavora. In quell’attimo capisco che io ho tutto, altri nulla».
Tornato in Liguria, racconta Oddera, “sentivo nello stomaco il verme che mi attraversava e non sapevo cosa fare”. Fino a quando non si ricorda di un amico (Chicco) che lavora in una casa per disabili ad Acqui Terme e decide di chiamarlo per proporgli di portare i ragazzi da lui: «Ricordo benissimo quella giornata. Prima mi sono messo a fare il buffone per rompere il ghiaccio, poi ho cominciato con la mia esibizione: salti, accelerazioni. Finito lo show, un ragazzo viene da me e mi dice: “mi fai provare?”. Per qualche secondo la frase mi martella, poi lo prendo in braccio, lo carico fra me e il manubrio e lo porto in giro per i campi. Lui urla, ride, piange. Quando ci fermiamo ha il volto trasfigurato: mi dice che era stata la cosa più bella che avesse mai fatto».
Vanni Oddera inventa così la “mototerapia”. A ogni esibizione si ferma sempre un po’ di più, piano piano altri amici si uniscono poi a lui e insieme costituiscono i “DaBoot”, circa venti motociclisti che gratuitamente fanno circa 50 date all’anno di show, in giro per il mondo: «Già quando accendo la moto e li faccio mettere vicino alle rampe sentono la botta dentro. Il rumore è mostruoso, l’aria si sposta. Quando finisco, li invito a salire con me. Così possono provare anche loro l’ebbrezza della velocità, la sensazione di libertà. Per ragazzi che passano la vita in sedia a rotelle salire in moto è una bomba».
La mototerapia ha effetti positivi: c’è il ragazzo bielorusso malato di tumore che riprende a comunicare con gli altri, dopo essersi chiuso in se stesso; ci sono i bambini dei reparti di ematologia e oncologia di alcuni ospedali italiani che letteralmente si esaltano; c’è la forza della “catena umana” che fa sì che un hotel metta a disposizione la propria struttura per le famiglie dei bambini ricoverati al Gaslini di Genova, gratuitamente.
«Che bello sentire il vento sulla faccia»: la frase che Vanni si sente ripetere più spesso. Il vento sulla faccia. Come le onde del mare o la neve per chi non le ha mai viste.
La felicità spesso è nelle piccole cose, nella routine distratta delle nostre vite: situazioni alle quali non diamo importanza perché sono a portata di mano, perché ci sono sempre state come l’aria che respiriamo.
La lezione di Vanni Oddera è che per fare del bene “basta che ognuno usi la sua passione come chiave per interagire”: «Non serve fare salti mortali». E se lo dice lui, ci crediamo.

*Le frasi riportate tra virgolette sono estratte dall’articolo di Fausta Chiesa: La sfida del centauro: «Vi porto tutti in moto», contenuto in “Buone Notizie”, inserto del Corriere della Sera, 7 novembre 2017)
Quella maledetta domenica che si portò via il Sic
Per qualche anno ho gestito un secondo blog, nel quale scrivevo quasi esclusivamente di Inter: un blog da tifoso, con l’immancabile rubrica del commento alle partite e amenità varie, ma che ogni tanto utilizzavo anche per commentare eventi di altre discipline sportive. Oggi che ricorre il quinto anniversario della sua tragica morte sul circuito di Sepang voglio ricordare Marco Simoncelli con il post che scrissi allora.
Mentre ero in volo, di rientro da Londra, pensavo che sarebbe stata una delle poche domeniche in cui non avrei visto alla Tv la partita dell’Inter. Sarei riuscito ad ascoltare gli ultimi minuti di radiocronaca in macchina, di ritorno dall’aeroporto di Lamezia. Ed infatti è andata così. Proprio per questo motivo avevo pensato di scrivere qualcosa su questa esperienza inedita e antica allo stesso tempo. Sarebbe stato un tuffo nel passato, un amo lanciato nel mare dei ricordi dell’infanzia per ripescare un mondo senza Sky né Mediaset. Un tempo in cui del cartello delle partite, disputate tutte rigorosamente di domenica, riuscivamo a vedere – e con quale attesa! – soltanto la differita del secondo tempo dell’incontro di cartello su Rai 2 verso le 19.00, dopo i saluti di Paolo Valenti dietro la scrivania del suo “Novantesimo minuto”, su Rai 1.
Avrei raccontato di ragazzini attorno a una radiolina e dei “grandi” sulle auto parcheggiate davanti alla pineta comunale, al municipio, ai bordi delle piazze, accanto ai marciapiedi. Delle vecchie schedine del totocalcio con le matrici che andavano benissimo per aggiornare i risultati e che passavano di mano in mano, in una sorta di rito collettivo che dà l’idea di quanto il calcio fosse davvero un romanzo popolare.
Appena entrato in casa, invece, dopo i saluti è arrivata la domanda di mia mamma. Una domanda che nel tono delle parole e nell’espressione del viso conteneva già la risposta: «Hai saputo di Simoncelli?».
Stamattina, mentre preparavo le valigie, con un occhio seguivo nella televisione la gara di Moto2. C’era stato un incidente che aveva coinvolto lo spagnolo Axel Pons, con la conseguente sospensione della gara a due giri dal termine. «Pista pericolosa», mi ero detto.
Le parole di mia mamma sono state un déjà-vu, la mia mente è corsa all’incidente in cui perse la vita Ayrton Senna, nel Gran Premio di San Marino. Allora, durante le prove, era morto Roland Ratzenberger, mentre Rubens Barrichello si era salvato per miracolo. Incidenti premonitori, anche in quel caso, che anticiparono la morte di uno dei più grandi piloti di sempre. Un personaggio amatissimo, come lo era il Sic.
Mancano le parole per descrivere la tragedia che si porta via delle giovani vite. Da domani si parlerà di sicurezza, del gioco che forse non vale la candela, di ragazzi che hanno tutto – soldi, successo – e che ogni tanto perdono tutto in una curva maledetta o per un guasto meccanico.
Da domani si parlerà anche – ed è giusto che sia così – di Marco Simoncelli, del suo essere irregolare e solare: sempre con il sorriso, un po’ guascone, duro quanto serve per sgomitare in pista e staccare un secondo dopo l’avversario. Quel secondo che ti consente di passare davanti e di mandare il pubblico del tuo show in delirio. Un ragazzo che nel paddock era amato per la sua allegria, per i suoi scherzi, per il suo non prendersi mai troppo sul serio. Per essere, in fondo, un giovane innamorato della vita.
Ora però è bene che si fermi tutto. Ci sarà tempo per altri articoli. Ora è il tempo del dolore e del rimpianto per una vita spezzata nel fiore degli anni.
[23/10/2011]
La lezione di Ranieri
«È un po’ come se il mio Catanzaro avesse vinto il campionato». Di nuovo Catanzaro come termine di paragone. Alle aquile giallorosse Claudio Ranieri aveva già fatto riferimento quando gli era stato chiesto a quale esperienza calcistica era paragonabile il suo Leicester. Si era ancora ai primi di febbraio, sportivi e addetti ai lavori cominciavano a chiedersi quale fosse il segreto di una squadra ritrovatasi a sorpresa in vetta alla Premier League. Alla domanda di Mario Sconcerti su cosa potesse paragonare la propria squadra, dalle colonne del Corriere della Sera Ranieri non citò nessuno dei club blasonati che aveva allenato in precedenza: «Alla fine della carriera da giocatore ho trovato una squadra così: era il Catanzaro di Gianni Di Marzio, di Palanca, Silipo e gli altri. Capisco non sia un grande esempio, meglio Guardiola. Ma quella era una squadra come il Leicester, un gruppo di amici che viveva insieme». Ed è stato commovente vedere le lacrime di Fausto Silipo alla Domenica Sportiva, lacrime di emozione per il successo ottenuto dall’amico di sempre. Spirito di gruppo, ecco la chiave del successo: il collante che da quarant’anni tiene insieme i calciatori di quel Catanzaro e che, ora, ha fatto sì che diventasse realtà il sogno del primo scudetto in 132 anni di storia delle volpi blu, quotato 5.000 a 1 dai bookmakers inglesi.
La vittoria dell’organizzazione e della forza di volontà. Una vittoria romantica che si fa beffe delle campagne acquisti faraoniche, ma anche una vittoria che le aziende stanno già studiando per capire se il “modello Ranieri” è esportabile in altri settori. Come ottenere grandi risultati con pochi soldi a disposizione, puntando tutto sull’aspetto motivazionale.
Da tre giorni le televisioni inglesi non parlano d’altro. Un inviato della BBC ha setacciato il Testaccio alla scoperta dei luoghi dove Ranieri è cresciuto, raccogliendo anche la dichiarazione in romanesco del fioraio (“Claudio è l’unico con la testa sopra le spalle”). Per Leicester si prevede addirittura un aumento dei flussi turistici, grazie all’impresa compiuta dai ragazzi di “Claudio” (non di “Mr. Ranieri”), che è parte integrante della comunità (“è uno di noi”), con le sue passeggiate al mercato della frutta o la spesa al supermercato, le sue soste con la gente comune per parlare, stringere mani, concedere selfie. L’idolo delle signore over 55, le quali utilizzano come sfondo del display del telefonino la foto con Ranieri, una persona “educata e seria”, un “gentiluomo d’altri tempi” che fa anche “un buon odore”!
Ranieri fa fare bella figura all’Italia. L’immagine dell’italiano all’estero, simpatico e dalle buone maniere, ne esce rafforzata. Il suo è anche il successo di chi ce la fa fuori dal Bel Paese, che se da un lato riapre l’annosa questione della fuga dei cervelli, dall’altra dà linfa al sentimento dell’identità nazionale e dell’orgoglio italiano tra gli emigrati italiani.
Ma la lezione più importante di questa favola l’ha sintetizzata, con semplicità e umiltà, Ranieri stesso, dichiarando a caldo: «L’unica cosa che posso dire a tutti quanti è di crederci sempre. Provateci, non solo nel calcio, ma in tutti i campi della vita». A dispetto di ogni teoria rottamatrice che voleva il sessantaquattrenne Ranieri alle ultime panchine in squadre di seconda e terza fascia, ormai destinato a concludere la carriera senza vincere un campionato di calcio, questa storia insegna che c’è sempre tempo per realizzare i propri sogni, che non bisogna mai arrendersi e che esiste sempre un’altra possibilità finché si ha la forza di crederci. E quindi: God save the coach!
Diagonale imparabile all’ultimo chilometro
L’epica sportiva sublima la dimensione umana. L’atleta raggiunge il rango delle divinità, prende posto tra i convitati del banchetto olimpico e si inebria di ambrosia. Diventa un dio in terra. Lo sport è poesia perché è fatica e sudore, superamento dei propri limiti, ascesa. È poesia perché è metafora della vita e una vita senza poesia è vita a metà.
I dieci racconti di Diagonale imparabile all’ultimo chilometro (Laruffa, 2010), che fonde nel titolo la magia dei due sport protagonisti del libro scritto dal giornalista del Tg2 Enzo Romeo, non sono soltanto nostalgia del tempo andato, degli anni in cui il business stava ancora fuori dalla porta degli spogliatoi o delle camere d’albergo. La nostalgia è presente e fa anche parte della biografia dell’autore, figlio del presidente della Reggina nel 1946 e ciclista amatoriale a Siderno negli anni Settanta: “Trigòni era il nostro Tourmalet, il nostro Stelvio”. Ma la nostalgia non è l’unica chiave di lettura del bel libro di Romeo. C’è dell’altro.
Ci sono i sogni di una generazione che si è identificata nelle prodezze leggendarie dei miti dello sport, che ha lottato per riscattarsi sul piano sociale con la stessa tenacia degli eroi che correvano dietro a un pallone o si alzavano sui pedali, pronti per lo scatto finale. Con la testardaggine di Fiorenzo Magni, che corre la metà delle tappe del Giro d’Italia con la clavicola e con l’omero fratturati, stringendo tra i denti un tubolare legato al manubrio della bicicletta.
C’è il riscatto “chiamato football club” del MYSA (Mathare Youth Sports Association), avventura iniziata nel 1987 in una baraccopoli di Nairobi e arrivata alla candidatura del Nobel per la Pace, grazie a un sistema formativo basato su tutta una serie di attività sportive, ma anche culturali e artistiche, ricreative e sociali, diventato un modello oggi imitato in molti Paesi.
Pagine di poesie vere, come le Cinque poesie per il gioco del calcio di Umberto Saba. Pagine di cronaca sportiva che sono esse stesse poesia perché vergate da Alfonso Gatto, poeta al seguito del Giro d’Italia per «l’Unità» il cui linguaggio iperbolico ha fatto scuola.
Vittorie e cadute, nello sport come nella vita. La storia di Erminio Bercarich, profugo fiumano approdato a Reggio Calabria nel 1946, che esordisce contro il Lentini indossando uno dei maglioni bianchi di lana offerti dalla tifoseria. Capocannoniere assoluto nella storia della Reggina con 75 reti, appese le scarpette al chiodo sparì, dimenticato da tutti. L’attimo di gloria vissuto da Angelo Mammì, autore del tuffo nel fango che, nel 1972, valse la storica vittoria del Catanzaro sulla Juventus, raccontata da Enrico Ameri e dal tifoso entrato nella sua cabina gridando a squarciagola: «Gol!». Joachim Rafael da Fonseca, ala destra nello Sporting Lisbona vincitore negli anni Sessanta di due campionati, una Coppa del Portogallo e una Coppa delle Coppe, che si ritira dal mondo e diventa Fra Paolo, monaco di clausura nella Certosa di Serra San Bruno, dedito al silenzio e alla preghiera.
Storie note e meno note, avvolte dal fascino della leggenda e dal mistero dell’esistenza umana. Racconti di sport e di vita, per chi ama lo sport e la vita.
Noi che tiravamo pallonate
Campi che non finivano mai, larghi fino al confine della strada, lunghi fino alla sipala intricata di spine, dove riprendere il pallone che vi si era cacciato dentro diventava impresa da genio guastatore. Da pagare al prezzo dei pezzetti di stoffa strappati e impigliati tra i rovi, delle grancinate e delle ’rdicate che sembravano appiccare il fuoco alla pelle.
Era il calcetto pionieristico giocato nelle piazze e nelle strade, nelle periferie abbandonate, ovunque si potessero piazzare a terra due bottiglie o due mattoni per farne i pali della porta. La traversa come ipotesi, collocata a un’altezza indefinita: 10-15 centimetri sopra le dita stirate del portiere, calcolo approssimativo del salto che un ragazzino poteva compiere balzando dal suolo. Una linea orizzontale immaginaria che talora si materializzava nella riga tracciata con la vernice (ma anche con un paio di gessetti recuperati a scuola) sulle saracinesche o sul muro. Circostanza che comunque non impediva di stabilire senza eccessive contestazioni – e senza l’ausilio della moviola in campo – se fosse gol o meno, anche nelle situazioni di più difficile interpretazione. Graffiti di primavere lontane che su qualche parete resistono, tenaci come i tackle affondati nonostante il cemento, le ginocchia ’mprascate di sangue.
Un calcio da artisti di strada che odorava di libertà e di fantasia, che non viveva prigioniero degli schemi e delle divise delle scuole di calcio per bambini. Che considerava naturali la camicia e finanche i mocassini. Che a casa, a sera, riportava appiccicati sul viso sudore e terra.
Bastava essere in due: uno contro uno, trasposizione calcistica degli antichi duelli d’onore. In tre, il terzo diventava una sorta di arbitro dalle cui parate dipendeva l’esito della sfida. Ma in tre si poteva anche optare per la “modalità allenamento”: passaggi e tiri contro quello che fungeva da portiere fino a quando non riusciva a respingere una conclusione. Due contro due, con “portiere volante”. Due contro due, più il portiere fisso. Tre contro tre. E così via. Varianti pratiche e flessibili che consentivano il massimo dell’aggregazione possibile. In proposito non esisteva alcuna regola, se non quella inconsapevole e riassumibile nel motto di don Italo Calabrò: “nessuno escluso, mai”.
Ogni rione di Sant’Eufemia ha luoghi della memoria fatti di pallonate e vetri rotti, maglie sdillabbrate dalle trattenute (i falli esistevano soltanto nei casi di tentato omicidio) e scarpe aperte nella punta, immagini sfuocate di partite senza fine: «vince chi arriva prima a cinque gol»; ma poi si prolungava a dieci, a venti, o fino a quando non imbruniva ed era ora di rientrare.
La “Pezzagrande” contava il numero maggiore di campi di gioco improvvisati. All’interno della pineta comunale, con al centro il cerchio di cemento rialzato, una porta tra due alberi non perfettamente allineati e l’altra vagheggiata tra due pietre sistemate ad alcuni metri di distanza dal punto in cui il terreno digradava verso gli orti. Nel “Giardinello” polveroso, scenario piratesco di scorribande a caccia di ciliegie, ma anche di fughe precipitose, inseguiti dal cane aizzato contro i ragazzini dal massaro esausto ma minaccioso con la faccetta in pugno. E poi la mitica piazza Municipio con le sue “pietre di Catania”, al primo posto nella speciale classifica delle cause di distorsioni e fratture tra gli adolescenti. Piazza Matteotti, dove la scelta del pallone dipendeva dalle restrizioni vigenti: dal Tango al Super Santos, dal Super Tele al pallone di spugna, dalla pallina di tennis a quella di spugna, fino al prodigio della lattina di bibita schiacciata. Ma si giocava anche nel catino dell’ex pescheria, nelle strade aperte al traffico e in quelle chiuse, con buona pace per la squadra cui toccava correre in salita.
D’altronde, quando in palio c’era la supremazia rionale, il campo sportivo diventava teatro delle sfide campali tra selezioni di undici giocatori. Ed era come disputare un mondiale.
C’era una volta il tennis
Chi non hai mai provato la sensazione di trovarsi in una circostanza “già vista”? L’improvviso riemergere nella memoria di ricordi sospesi tra sogno e realtà è il fenomeno del déjà vu: un passante che ci sfiora, una frenata brusca con l’automobile, un profumo, un suono che appartengono a una situazione già vissuta nel passato. Che sappiamo come andrà a finire, mentre si svolge.
A me capita entrando in pineta, soprattutto quando la primavera sta per esplodere. Il sole tiepido di marzo mi riporta agli anni del tennis, ormai lontanissimi nella memoria mia e del paese. Da oltre un decennio il campo da tennis vive infatti una condizione di abbandono ed è incredibile come nessuno riesca a rilanciare una disciplina sportiva che ha avuto stagioni gloriose. Uno sport che ha aggregato generazioni di eufemiesi e reso vivace un angolo di paradiso, quale è la nostra pineta comunale con la sua brezza fresca, che d’estate è un balsamo miracoloso per coloro che soffrono il caldo.
La vitalità di un paese si misura dal rapporto virtuoso che l’uomo riesce a instaurare con l’ambiente che lo circonda. L’abbandono è sinonimo di morte. Quanti sono nel nostro paese, oggi, gli spazi morti? Beninteso, ciò dipende pure da una socialità che è parecchio mutata rispetto anche soltanto a due decenni fa e che è – ahimè – prevalentemente “virtuale”.
Fatto sta che i luoghi di aggregazione stanno sparendo. Di sicuro è svanita la loro originaria funzione. I cortili sono ormai scomparsi o, se ci sono, hanno perso l’antico fascino di luogo in cui le famiglie condividevano con i vicini della porta accanto gioie e dolori. Le strade servono soltanto a collegare un posto con un altro, ma sono prive di calore: quasi scomparse le biciclette, per non dire dei palloni che rotolavano lungo le discese mentre dietro orde di ragazzi si affannavano per raggiungerli. Le piazze sempre più vuote o comunque non “vissute”: giusto qualche bambino, finché non raggiunge l’età che gli consente di affrancarsi dalla tutela dei genitori.
La pineta di venti, trenta, quarant’anni fa per molti eufemiesi è il posto delle fragole, perché rimanda all’innocenza e alla felicità di tempi che non torneranno mai più, all’adolescenza fatta di sogni e semplicità. Tra i suoi alberi sono nati amori, altri sono naufragati. Sulle sue panchine si sono accomodati migliaia di giovani e meno giovani. Sono queste le scene che rivedo quando ne varco l’entrata. Nonostante sia cambiata “fisicamente”, se si chiudono gli occhi e si sta in silenzio, è possibile ascoltare la vita trascorsa.
In questo passato c’è il tennis, che tutti abbiamo praticato. Con la racchetta di legno, prima che esplodesse la mania dei più moderni semiracchettoni. Tutti. Quelli che non sono mai riusciti a impostare il rovescio. Quelli che “forzavano” prima e seconda battuta. I “pallettari” che attendevano sempre l’errore degli avversari. Da marzo a settembre-ottobre era una gara a chi riusciva a prenotare il campo. Sempre occupato. E poi, d’estate, i tornei con 50-60 partecipanti: tutti affascinati dall’abilità con cui Rocco Vizzari riusciva a comporre i tabelloni di singolare, doppio e doppio “giallo”, tra teste di serie e turni preliminari, per dare a tutti almeno una chance di passaggio del primo turno.
Perché quel movimento è scomparso? Certo, il “pensionamento” di un fuoriclasse dell’organizzazione come Rocco Vizzari ha inciso parecchio. L’emigrazione universitaria e lavorativa di due-tre generazioni trainanti ha fatto il resto. Tuttavia, a mio modo di vedere, a un certo punto sono mancate le condizioni minime per poter continuare. Vale a dire: un impianto tenuto in discrete condizioni e un custode responsabile.
Per rilanciare il tennis e rivitalizzare la pineta comunale occorrerebbe ripartire da qua. Riprendere quel filo, spendendo pochi soldi per sistemare la recinzione, comprare la rete e pitturare il campo; quindi affidarne a qualcuno la gestione, stabilendo orari di apertura e di chiusura della pineta (se la videosorveglianza implica dei costi eccessivi) per evitare che i soliti vandali distruggano quanto di bello il nostro paese ha da offrire.
Forza Eufemiese
I campionati di calcio giovanili e le categorie dilettantistiche sono come il militare: periodi “mitici” che si finisce per ricordare negli anni, magari davanti a una bottiglia di vino o a una birra ghiacciata, tra vecchi eroi del tempo andato. Ancora oggi a quelli della mia generazione capita di ricordare la “lotta” tra ragazzini di 13-14 anni, in occasione delle trasferte, per salire su una Fiat 131 blu sulla quale una volta ci stringemmo in nove (più i borsoni). La nostra automobile preferita. Merito del simpatico autista che aveva sempre aneddoti curiosi da raccontare e che, puntualmente, all’altezza dell’uscita di Gioia Tauro, faceva scendere uno o due passeggeri: insomma, quelli che eravamo in soprannumero. Dall’autostrada ci arrampicavamo sul cavalcavia, lui superava in tranquillità l’eventuale posto di blocco della polizia, quindi ci riprendeva a bordo. Perfezione geometrica. La Fiat 126 bianca di Peppe Napoli, che chissà quanti chilometri ha macinato in giro per la provincia, e poi altri bolidi: la Fiat 127 rossa sulla quale al ritorno da Bagnara una volta consumammo un’intera cassetta di fragole; il “maggiolino” della Volkswagen con optional “vista sull’asfalto”, grazie a un buco nella carrozzeria coperto dal tappetino; la Citroen due cavalli, che in teoria non avrebbe mai dovuto cappottarsi: impresa realizzata dal suo proprietario, per fortuna non con noi a bordo.
Amicizie nate nello spogliatoio e intatte decenni dopo, grazie a una passione che andrebbe sempre trasformata in occasione di crescita sociale e umana, collettiva e individuale. Altrimenti non ha senso. Non so se provare tenerezza o sorridere per quelli che si creano chissà quali aspettative. Bisognerebbe invece capire che uno su trecentomila ce la fa e che la finalità di una squadra di calcio dilettantistica non è quella di creare campioni. Anche se qualcuno bravo ogni tanto salta fuori e riesce anche ad avere anche una discreta carriera. Anche se alla fine a nessuno piace perdere. No, il calcio a questi livelli e in queste realtà – come qualsiasi altra attività sportiva – è qualcosa di molto importante proprio perché va al di là della prestazione e del risultato. Vincere o perdere non è tanto questione di un gol in più o in meno. Vincere o perdere è riuscire ad essere fattore di aggregazione, trasmettere valori positivi a ragazzi che domani diventeranno adulti. Condivisione, rispetto, responsabilità e sacrificio: talenti che vanno oltre la pratica sportiva, elementi fondamentali del percorso di maturazione che ogni ragazzo vive.
Lo so che sono di parte, perché è mio amico e perché per molti anni su quella Fiat 126 bianca ci sono salito ogni settimana, per andare a volte in posti impossibili nei quali non sono mai più ritornato: Cataforio, ad esempio.
Dirigenza, allenatori e giocatori passano, ma lui c’è sempre: da almeno 35 anni dici Eufemiese (ora A.C. Sant’Eufemia) e inevitabilmente pensi a Peppe Napoli. Una passione che non ha mai flessioni, nonostante le difficoltà di un impegno gravoso anche sotto l’aspetto organizzativo. Domani inizia il campionato di Seconda categoria, che avrà tra le protagoniste l’Eufemiese (io la chiamerò sempre così): un grosso in bocca al lupo a Peppe Napoli, a mister Franco De Luca, ai collaboratori e ai ragazzi. Forza Eufemiese!