Come gli “strumentisti sessionmen” di Enrico Ruggeri, anche Berlusconi ha “già sviluppato il refrain”. Lo fa ormai da diversi anni, ma ancora funziona. Prima, parte lancia in resta; poi, verifica la reazione ai suoi attacchi; infine, se le cose si mettono male, è colpa dei giornalisti che “travisano” il suo pensiero. Per una forma di captatio benevolentiae, al congresso dei cristiano-riformisti il premier ha pensato bene di sferrare un attacco sommario al “relativismo etico” della sinistra “che non difende la sacralità della vita, inneggia alle coppie di fatto e cerca di imporre la cultura della morte e dell’eutanasia”. Dimentico, ovviamente, della giustificazione “dentro le mura di casa mia faccio quello che voglio”, uno dei massimi esempi di relativismo etico. Una performance bollata da Anna Finocchiaro come il solito “stanco repertorio”, nel quale non poteva mancare l’attacco ai comunisti italiani, gli unici ad essere rimasti uguali ai sovietici delle purghe staliniane.
Si sa che il presidente del consiglio è imbattibile nella capacità di conformarsi all’interlocutore che ha di fronte. È di pochi giorni fa – discorso tenuto nell’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola ufficiali – la sortita sul sogno giovanile di diventare carabiniere. D’altronde, in materia di rapidità nel cambio degli abiti di scena, l’Italia ha una storica tradizione, dal mitico Leopoldo Fregoli ad Arturo Brachetti, “l’uomo dai mille volti”. Ma questa volta Berlusconi è andato addirittura oltre la semplice strizzata d’occhio al Vaticano, dettata dall’esigenza di dare una lustratina all’immagine appannata e ammaccata dalle rivelazioni sulle sue poco morigerate abitudini. È arrivato così l’affondo contro la scuola pubblica, accusata di inculcare “idee diverse da quelle che vengono trasmesse nelle famiglie”. Una sorta di spot per le scuole private (in gran parte cattoliche), ma anche un insulto gratuito nei confronti dei tanti che lavorano in condizioni rese oggettivamente più complicate dai tagli della Gelmini. Persino il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana, deve avere trovato eccessivo il discorso del premier, se ha sentito il bisogno di esprimere la fiducia della Chiesa nella scuola pubblica italiana.
Il problema della scuola non è l’ipoteca ideologica che su di essa eserciterebbe una parte politica. La scuola pubblica non ha niente a che fare con le Frattocchie, tanto per essere chiari. Il dramma sono quegli insegnanti a proprio agio con la grammatica e la sintassi quanto un pastore tibetano con le immersioni subacquee. Laureati che scrivono “qual è” con l’apostrofo, “accelerare” con due elle, “ce ne sono” con un profluvio di apostrofi e accenti, e via strafalcionando. Esiste un problema di preparazione del personale docente, dovuto alle scellerate politiche governative che negli ultimi decenni hanno praticamente concesso a chiunque la possibilità di insegnare. E c’è la questione, per responsabilità non tutte imputabili alla scuola intesa come istituzione, dello scarso riconoscimento (status, autorevolezza, ruolo) attribuito agli insegnanti. Ma le affermazioni irresponsabili non sciolgono i nodi, sono utili soltanto per completare e giustificare lo smantellamento dell’intero sistema scolastico pubblico.
Italia milionaria
Con la corrosiva ironia che lo contraddistingueva, Leo Longanesi metteva a nudo l’endemico familismo italico sostenendo che sul tricolore andrebbe stampato il motto “tengo famiglia”. Eppure, un limite alla sfrontatezza non guasterebbe. Quando Fabrizio Cicchitto indica nel Pdl l’estremo baluardo della democrazia italiana contro l’ingerenza e lo strapotere della magistratura politicizzata, che “vuole sovvertire il voto popolare”, calpesta Montesquieu e oltre 250 anni di civiltà giuridica fondata sul principio della separazione dei poteri, non sul consenso elettorale inteso come diritto all’impunità. Da questo punto di vista, anche l’ultima uscita di Berlusconi sulla necessità di riformare la Corte costituzionale perché “boccia leggi giuste” rappresenta l’ennesimo affondo contro un organo dello Stato, oltre che il sintomo dell’allergia per quel sistema istituzionale di checks and balances che sta alla base delle democrazie contemporanee. Sull’incoerenza logorroica di Daniele Capezzone esiste ormai una sconfinata letteratura: il confronto tra le dichiarazioni rese dall’ex pupillo di Marco Pannella prima che diventasse portavoce del Pdl e quelle oltranziste a difesa del premier è davvero sconcertante (per usare un aggettivo molto gradito dall’ex enfant prodige radicale). Per non dire dell’acqua che deve essere passata sotto i ponti da quando Daniela Santanchè affermava che il Cavaliere “non ha rispetto per le donne” e le concepisce “solo orizzontali, mai verticali”. È passata molta acqua e pure qualche poltrona visto che, da sottosegretario con delega all’attuazione del programma di governo, la signora più glamour della politica italiana è diventata la più devota e ascoltata consigliera del premier, una specie di Giuliano Ferrara in gonnella e randello. Dopo la battaglia condotta contro Fini per la vicenda della casa di Montecarlo e la promessa di un posticino al governo per il suo partito (e, si intuisce, un paio di candidature alle prossime elezioni), persino Francesco Storace, di recente, si è prodotto in una difesa del premier imbarazzante, che lascia intendere come neanche la destra dura e pura trovi scandaloso derogare ai suoi tanto decantati valori.
Non penso che l’indignazione sia un sentimento snob e radical-chic. Non credo neanche che ci troviamo di fronte a due mondi antropologicamente diversi. La triste parabola dei parlamentari di Futuro e libertà che con la coda tra le gambe stanno facendo rientro all’ovile, dopo essersi accorti che la spallata di Fini non ha avuto l’effetto immaginato, dimostra proprio quanto l’opportunismo prevalga su ogni altra considerazione.
Ha ragione Roberto Vecchioni, fresco vincitore del festival di Sanremo: “questa notte dovrà pur finire”. Che poi è il convincimento (“ha da passa’ ’a nuttata”) di Gennaro Jovine/Eduardo De Filippo in “Napoli milionaria”, di fronte allo sfascio etico dell’umanità sopravvissuta agli orrori e alla miseria della seconda guerra mondiale. Aspettando che passi la nottata, teniamoci stretta e difendiamo la Costituzione repubblicana: se in tutti questi anni l’Italia ha retto e non è diventata una repubblica sudamericana o la Russia putiniana, grande merito va alla Carta scritta dai nostri Padri costituenti.
Un destino cinico e baro
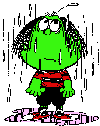
Per esprimere il disincanto con cui spesso si accoglie una notizia che si sa per certo non veritiera, dalle nostre parti si suole ricorrere ad un efficacissimo adagio: “Tu ’u dici ed eu cchiù sceccu criju ca prima veni giugnu e dopu maju”.
Il fatto nuovo, ormai di dominio pubblico, è che anche Eufemia Surace, consigliere e da pochi mesi presidente del consiglio comunale, si è dimessa, andando a infoltire la schiera di coloro che hanno abbandonato Saccà e la sua maggioranza. Ora siamo a tre, dopo il vicesindaco Pippo Ascrizzi e l’ex presidente del consiglio Tonino Alati. E anche questo è un record. Non penso che ci siano altre amministrazioni che abbiano perso per strada due presidenti del consiglio consecutivamente, subito dopo l’istituzione della carica. Diciamo che quella poltrona porta un po’ sfiga, per cui sarebbe forse il caso di tornare ai tempi in cui il sindaco presiedeva l’assemblea.
Al di là delle facili ironie e delle statistiche da consegnare agli archivi, va invece considerato che tre indizi fanno una prova, la dimostrazione cioè del fallimento politico dell’amministrazione comunale uscita vittoriosa dalle urne il 27 maggio 2007. I tre indizi, grossi quanto macigni, hanno volti e nomi ben precisi, e ognuno di essi porta con sé una storia politicamente significativa.
Andiamo con ordine. Il primo smottamento si registra questa estate, quando Tonino Alati saluta la compagnia tra il finto stupore della maggioranza e i sorrisi maliziosi dei cittadini, per nulla persuasi dalla motivazione ufficiale. La seconda spia rossa si accende di lì a qualche mese, a fine ottobre: anche Pippo Ascrizzi, vicesindaco di nomina esterna, dichiara l’impossibilità di proseguire l’esperienza amministrativa. Due giorni fa il terzo allarme con Eufemia Surace, anche lei (coincidenza?) dimessasi, come Alati e Ascrizzi, per “motivi personali”. Alati è stato per tre lustri, nella buona come nella cattiva sorte, tra i più fedeli e leali pretoriani di Saccà, a conferma di un sodalizio che andava ben oltre il rapporto politico. Il sorprendente accordo stretto con Ascrizzi ha costituito invece la più eclatante novità politica delle ultime consultazioni amministrative, tanto da diventare l’unico vero argomento della campagna elettorale. Un’altra sostanziale novità è stata infine Eufemia Surace, alla prima esperienza amministrativa ed espressione di un mondo, quello delle giovani donne, che rare volte riesce ad avere una rappresentanza istituzionale.
Fino ad ora il sindaco, barricato dentro il bunker del palazzo municipale, ha proseguito come se nulla fosse, supportato dai consiglieri che gli sono rimasti fedeli. L’indifferenza ai segnali inequivocabili della fine di un ciclo potrebbe ripetersi anche questa volta. Non ci sarebbe da stupirsi più di tanto. D’altronde, un politico navigato come Giuseppe Saragat, di fronte al fallimento della legge truffa fece una considerazione che di politico aveva ben poco: “la colpa è del destino cinico e baro”. Evidentemente, in questo momento la malasorte deve avere un conto aperto con il nostro Comune.
Il teatrino della politica
Un tema serissimo come la riforma federalista si è trasformato in un terreno di battaglia la cui posta in palio non è la revisione dell’impianto istituzionale dello Stato. Siamo dentro al solito ring, con contendenti che si producono nell’ennesima esibizione muscolare, senza alcuna capacità o volontà di confrontarsi sul merito delle proposte. È il consueto muro contro muro, tra mondi incapaci di parlarsi. A rimetterci è la politica, che gode ogni giorno di sempre minore credibilità, e il Paese, in costante affanno. È evidente che sul tavolo ci sono esigenze principalmente strumentali. E quando il collante si riduce all’opportunità politica del momento, è illusorio sperare in operazioni di ampio respiro.
L’approvazione, in fretta e furia, del decreto legislativo in materia di federalismo municipale che, di fatto, calpestava le prerogative di parlamento, regioni e enti locali (come ha ammonito il Colle dichiarando il provvedimento “irricevibile”), tradisce il comprensibile nervosismo della Lega, dopo la bocciatura del parere di maggioranza da parte della commissione bicamerale sul federalismo municipale. La forzatura procedurale – qualcosa di simile ad una “prova d’amore” – pretesa da Bossi per non fare cadere il governo, conferma la subalternità di Berlusconi nei confronti del Carroccio, il vero dominus dell’Esecutivo. Da questo punto di vista, l’irritazione attribuita al sempre equilibrato e felpato Gianni Letta, rappresenta la spia del crescente imbarazzo che serpeggia tra alcuni fedelissimi del premier, ormai stanchi di una “guerra santa” contro tutto e tutti, oggi il Quirinale, domani la magistratura, dopodomani il parlamento e la corte costituzionale.
Per dirla con parole prese a prestito dal gergo sportivo, la Lega aveva però l’esigenza vitale di portare a casa un risultato positivo. Non può presentarsi ad eventuali elezioni senza avere centrato l’obiettivo storico del federalismo, la ragione stessa della sua esistenza e del suo successo elettorale. Il popolo leghista dà segnali di insofferenza e comincia a non credere più al fortunato e abusato slogan di “Roma ladrona”. Tra tutti i partiti in Parlamento, il Carroccio è quello che più di tutti ha governato dal 1994 ad oggi, per cui diventa sempre più difficile sostenere una posizione di “purezza” contrapposta ad un mondo marcio. La Lega è parte integrante del sistema politico italiano e l’auto-rappresentazione di forza anti-sistema attecchisce sempre meno presso un elettorato disincantato da una gestione del potere non molto dissimile da quanto avveniva nella nefanda Prima Repubblica. Nell’attuale quadro politico, fatto di annunci e propaganda, Berlusconi non può permettersi il lusso di fare “brutta figura” con il prezioso alleato. Pare infatti che, di fronte al risultato della votazione nella commissione bicamerale, Bossi sia sbottato: “A me delle questioni interpretative frega niente, qui c’è una questione politica. E questo è il momento di vedere se abbiamo le palle”. Mentre, a sbrego costituzionale compiuto, avrebbe esultato: “La Lega mantiene le promesse e porta a casa un risultato concreto nell’interesse dei cittadini”.
La disinvoltura con cui sono state calpestate fondamentali prerogative istituzionali dovrebbe indignare chiunque possegga un minimo di senso delle istituzioni. Non Berlusconi, che al momento ha anche l’esigenza di guadagnare tempo e spostare il più in avanti possibile la data delle possibili elezioni politiche. Posizione, questa, condivisa anche dalla Lega, poco propensa a ricoprire in campagna elettorale lo scomodo ruolo di difensore del premier davanti al proprio elettorato, tutt’altro che indulgente da quanto si intuisce ascoltando alcune telefonate a Radio Padania. Proprio per questi motivi, l’opposizione ha intravisto la possibilità di rientrare nel gioco e tenta di inserire un cuneo tra Bossi e Berlusconi, facendo intendere che con un’altra compagine la riforma non incontrerebbe alcun ostacolo. Per commentare l’attuale condotta del premier è stato rispolverato l’andreottiano “tirare a campare”: “meglio tirare a campare che tirare le cuoia”, rispose un giorno il divo Giulio a chi contestava la sua filosofia di vita. Essere giunto ad una situazione del genere rappresenta il contrappasso più crudele per chi era “sceso in campo” per sconfiggere il teatrino della vecchia politica.
Il prezzo del rinnovamento
Diciamoci la verità, appare lievemente ipocrita questo stracciarsi le vesti perché non si riesce ad arrestare l’emorragia del partito democratico calabrese. Come nei castelli di carta, tirata via una tessera viene giù tutto. Anche se basta una bava di vento, non certo un uragano. Figurarsi dopo una batosta come quella delle passate elezioni regionali.
Fino a non molto tempo fa si rimproverava al Pd di essere arroccato a difesa della rendita politica di pochi oligarchi. Oggi che ci si sta liberando di un personale gerontocratico e autoreferenziale si piange perché all’orizzonte non si intravede nient’altro che deserto. Eppure è illusorio pensare di condurre a termine a costo zero una rifondazione che elimini vecchie e resistenti incrostazioni. Soltanto dalle macerie è possibile ricostruire ex novo, se non si vuole continuare ad applicare palliative e litigiose toppe al buco. È un prezzo che occorre pagare, dopo che per venti anni a tutto si è pensato tranne che a preparare una fisiologica e necessaria successione politica. A meno che non si voglia considerare maturazione di un nuovo ceto politico la pura e semplice cooptazione al vertice imposta dai ras locali.
Con la fuoruscita dei vari Adamo, Bova e Loiero si può invece aprire una fase finalmente nuova, che segni una cesura netta con il più recente passato. E se, nell’immediato, inevitabilmente ci sarà da scontare qualcosa in termini di consenso elettorale, a lungo andare sarà benefica una rigenerazione che produca chiarezza facendo tabula rasa del passato. Una volta per tutte, si dovrebbe avere il coraggio di lasciare sull’uscio i signori delle tessere fasulle, il cui numero, in molti comuni, è stato superiore ai voti del partito nelle elezioni. Si dirà: è utopia, è sempre stato così. Ma ai tanti giovani che, nonostante i molteplici negativi esempi, coltivano una passione, non si può chiedere di avvicinarsi alla politica sbandierando abusati rituali da Prima Repubblica. Non ci si può nascondere che, tanto per fare un esempio, l’inciucio sulla legge 25 del 2001 che bandì il “concorsone” rappresenta, dopo dieci anni, una ferita ancora viva tra molti militanti e simpatizzanti. Così come le primarie taroccate dell’anno scorso non sono certo state un esempio di buona politica. Il disimpegno e l’astensionismo dilaganti hanno ragioni sulle quali per troppi anni si è evitato un dibattito serio.
Berlusconi non è un fungo
Di fronte alle nuove puntate degli scandali che con cadenza giornaliera ci vengono somministrate, è lecito porsi qualche interrogativo, senza per questo essere tacciati di fare del moralismo da quattro soldi. D’altronde, è stato rilevato da diversi sondaggi e la stessa opposizione ne ha dovuto prendere atto, “la rivolta non scatta”. L’opinione pubblica – a parte l’indignazione di una parte – non ha avuto una reazione vigorosa. Anzi, non è minoritaria la convinzione che nel privato ognuno possa fare quel che gli pare. Anche andare a prostitute con minorenni. È questo il dramma della nostra società. Dov’è il limite di quello che un tempo i bacchettoni da sagrestia chiamavano “comune senso del pudore”? Non si vuole certo tornare a quel periodo di integralismo (e bigottismo), però un uomo – che per di più ricopre un incarico pubblico – deve porsi qualche freno.
La rivolta non scatta per diversi motivi, alcuni banali, altri avvilenti. La mancanza di un’alternativa a Berlusconi: il vuoto pneumatico che si scorge dall’altro lato spinge molti cittadini a considerare meno dannoso Berlusconi, con le sue poche virtù pubbliche e i molti vizi privati, di una sinistra incapace di darsi un orizzonte politico credibile. La crisi economica, che rende meno “sentito” il tema della moralità dei politici rispetto alla quotidiana fatica di unire il pranzo con la cena. Ma anche il quadro desolante che emerge dalle intercettazioni. Diventa una comoda giustificazione affermare che Berlusconi è il male assoluto. Come se il presidente del consiglio non sia un prodotto della società italiana. Un mio professore era solito usare una metafora efficace per convincerci che l’avvento del fascismo non fosse un esito obbligato della crisi dello stato liberale. Un’altra strada era possibile, quella fatta intravedere da Francesco Saverio Nitti durante il suo governo, e per rafforzare il concetto di come lo statista lucano rappresentasse la possibilità di uno sbocco democratico, esclamava: “Nitti non era un fungo”. Non fu una parentesi Mussolini (contrariamente a quanto sostenne una frangia della cultura liberale), non è – per aggiornare la metafora – un extraterrestre Berlusconi.
I censurabilissimi e, secondo l’accusa, illeciti comportamenti del premier rispecchiano un diffuso degrado etico che induce a considerare il denaro e il successo i principali parametri per misurare il valore delle persone. Tutto il resto è secondario. Qualsiasi scorciatoia è ammissibile, anche quella che spinge una ragazza a travestirsi da infermiera per “curare” l’attempato potente con qualche prodigioso giochino erotico. E pazienza se Berlusconi “è diventato pure brutto”, “un po’ ingrassato”, “più di là che di qua”; addirittura, “una caricatura del Bagaglino”. L’importante è che sganci. Come confida una delle ragazze coinvolte nell’inchiesta, “un cristiano normale lavora sette mesi” per prendere l’equivalente di quanto si può ottenere (in nero) dopo una notte ad Arcore.
Sono sconcertanti quei parenti che incitano le ragazze a darsi da fare. Un fratello che incoraggia la sorella: “quello ci risolve tanti problemi a tutti, a mamma, a te e a me”; un papà che invita la figlia a svegliarsi per non essere scavalcata nella graduatoria delle preferenze; la mamma che chiede alla figlia quanto denaro è riuscita a scucire; un genitore che esclama: “magari!”, invece di sbranare il giornalista che chiede se la figlia sia fidanzata con un uomo di cinquant’anni più grande; l’altro che al turbamento della figlia per l’orgia cui ha assistito (“te la dico in una parola per essere fini, un puttanaio”) contrappone una comprensibile giustificazione: “davanti a quella cosa lì gli uomini sono tutti uguali”. Tutto questo fa cadere le braccia, ma fa anche riflettere sul fallimento delle principali “agenzie” educative: famiglia, scuola, chiesa. Se queste tre istituzioni non riacquisteranno la credibilità e l’autorevolezza perdute, sarà impossibile riemergere dal gorgo in cui stiamo affondando.
Aridaje…
Toccherà alla magistratura stabilire se i comportamenti del presidente del consiglio abbiano rilevanza penale e prefigurino i gravissimi reati contestati nelle trecento pagine dell’invito a comparire che gli è stato recapitato nei giorni scorsi: concussione e prostituzione minorile. I fatti, ormai noti, riguardano la famosa telefonata fatta dal premier alla questura di Milano per fare rilasciare Ruby “Rubacuori”, affidandola alla consigliera regionale lombarda Nicole Minetti (l’igienista dentale del premier diventata soubrette a “Colorado Café” e poi inserita nel listino bloccato della lista Formigoni) la quale, in realtà, appena fuori dal palazzo la consegnò ad una prostituta brasiliana. Sta però alle coscienze individuali – alla sua e a quelle di coloro che, silenziosi e accondiscendenti, gli stanno vicino – fare qualche considerazione obiettiva su uno stile di vita che, senza essere moralisti o bacchettoni, è quanto meno sconveniente per chi al cospetto del mondo rappresenta un’intera nazione. Senza girarci troppo intorno, ci troviamo di fronte ad un premier che, per usare il benevolo eufemismo del fido Ghedini, è un “utilizzatore finale” di escort. Il tentativo di spostare l’attenzione sulla violazione della privacy di Berlusconi, che ha ironizzato sul nuovo reato di “cena privata a casa del presidente del consiglio”, non fuga i sospetti sulle otto notti trascorse da Ruby ad Arcore e su tutto ciò che è emerso dalle indagini. Un giro di ragazze che vivono all’Olgettina, in appartamenti di proprietà di Berlusconi avuti in comodato d’uso gratuito (l’accusa sostiene in cambio di prestazioni sessuali), laddove aveva abitato la stessa Nicole Minetti prima della trafila che l’ha portata al Pirellone. Minetti che risulta indagata, con Emilio Fede e Lele Mora, per induzione e favoreggiamento della prostituzione (sarebbero stati loro a individuare, selezionare e mandare dal premier le ragazze), mentre Giuseppe Spinelli sarebbe l’uomo di fiducia che si occupava delle spese per il mantenimento delle ragazze a Milano Due. È ciò che aveva denunciato Veronica Lario, senza per questo essere querelata: un marito “malato”, circondato da personaggi che conoscendone le debolezze e i vizi organizzano tutto “a sostegno del divertimento dell’imperatore”. Uno spaccato desolante e stridente con quanto viene propagandato in vista delle possibili prossime elezioni. La foto apparsa sulla copertina di “Chi” pochi giorni prima che riesplodesse lo scandalo, volta a trasmettere l’immagine della famiglia perfetta, radunata per celebrare le festività natalizie, è marketing elettorale.
Il presidente dei senatori della Lega, Federico Bricolo, sostiene che “i cittadini non capiscono come mai l’attenzione sia rivolta a Berlusconi e non ai criminali”. Forse è sempre il vecchio discorso della moglie di Cesare, che deve essere al di sopra di ogni sospetto, essere morigerata e, soprattutto, apparire tale. Che l’abitazione di Berlusconi sia frequentata da escort dovrebbe provocare un moto di indignazione, non fare gridare al complotto. Com’è possibile che una ragazza come Ruby, sbandata e scappata da una comunità, sia finita ad Arcore? E come è possibile che una prostituta (la brasiliana che telefonò a Berlusconi per dirgli che Ruby era finita in questura) abbia il numero di telefono del presidente del consiglio?
Umanamente fa pena una persona anziana che trascorre con una escort la notte di San Valentino. Siamo di fronte ad un uomo solo, molto solo. Ma anche alla realizzazione del feroce avvertimento di Cetto La Qualunque: “ricordatevi che voi siete la fiction, io la realtà”.
C’è molta confusione sotto il cielo del PD. La situazione dovrebbe essere eccellente (ma non lo è)
Come Jacques de La Palisse, il generale francese morto in battaglia a Pavia nel 1525, anche il partito democratico “se non fosse morto sarebbe ancora in vita”. La parabola elettorale del PD dimostra come in politica quasi mai due più due fa quattro. Il tentativo di fondere due tradizioni importantissime nella storia della Repubblica italiana, quella cattolica e quella comunista, è stata un’iniziativa nobile e per certi versi romantica. Ora però occorrerebbe prendere atto che l’esperimento è fallito miseramente e che, probabilmente, sarebbe il caso di fare un passo indietro. Se errare è umano, perseverare, in questo caso, è masochista. È evidente che alleati ma separati si ottengono risultati più positivi, alla faccia della vocazione maggioritaria del partito e di un bipartitismo impossibile nel nostro sistema politico. Lo dice anche la storia. L’unificazione socialista realizzata nel 1966 fu sonoramente rispedita al mittente dagli elettori due anni più tardi, quando PSI e PSDI ottennero, insieme, il 4,5% di voti in meno rispetto a quelli conquistati, separatamente, nelle precedenti elezioni. Guarda caso, una percentuale quasi identica a quella ottenuta dal PSIUP, che in quell’occasione realizzò l’unico exploit della sua breve esistenza. Nenni e Saragat, che non erano fessi, compresero che quella bocciatura esprimeva la rivendicazione di un elettorato che voleva custodire gelosamente la propria identità. Per cui preferirono fare ritorno ai rispettivi alvei partitici.
E poi, cos’è, oggi, il PD? Qualcuno sarebbe in grado di spiegarne strategia e linea politica? La sua classe dirigente è sempre impegnata a rincorrere e strattonare la giacca di chi, incidentalmente e per le più svariate ragioni, sembra essere in grado di mettere in difficoltà Berlusconi. Lo ha fatto con Fini, con Casini, con Montezemolo, con Emma Marcegaglia, addirittura potrebbe essere disposta a farlo con Tremonti. Ma così non si va da nessuna parte. Altrimenti avrebbero dovuto puntare su José Mourinho o Veronica Lario, gli unici davvero in grado di appannare l’immagine di invincibile che il premier con ostentato auto-compiacimento promuove. A furia di flirtare con il terzo polo, nell’attesa messianica di un incidente di percorso che azzoppi definitivamente il presidente del consiglio, il PD si è ridotto a fare il figurante di una rappresentazione in cui i protagonisti sono altri. Guardiamo a casa nostra, in Calabria. C’è un commissario, Adriano Musi, con un compito poco chiaro a lui per primo. Adamo e Bova, i dioscuri provenienti dalla tradizione comunista, al momento sono fuori dal partito. L’altro uomo forte del PD calabrese, Loiero, gioca da sempre una partita in proprio, nonostante la ricorrente puntualizzazione (excusatio non petita) di essere stato tra i fondatori del partito. Una posizione molto sui generis, certificata dall’esistenza di Autonomia e diritti. Il PD non è in grado di avanzare una candidatura credibile e seria né alla provincia, né al comune di Reggio. Per questo sembra cercare qualcuno da sacrificare (film già visto con la candidatura, alle passate comunali, di Lamberti-Castronuovo, praticamente abbandonato al proprio destino). Si parla di un “papa straniero”, De Sena o Minniti. Ma con quali criteri vengono scelti i candidati? Non occorre essere dei geni, basta possedere un minimo di buon senso per comprendere che in un comune il candidato a sindaco deve essere espressione del territorio per avere qualche possibilità di vittoria. Caratteristica che non appartiene, per mille motivi, né a De Sena, né a Minniti. Per la provincia, si attende la nascita del terzo polo e l’eventuale candidatura di Fuda. Come nelle passate regionali, il rischio è che, alla fine, un accordo UDC-PDL possa mandare tutto all’aria. Anche in questo caso, l’attendismo e l’immobilismo del PD risultano incomprensibili, e di corto respiro la sua strategia politica.
Il finale, scontato, rimanda alla celebre scena in cui Fantozzi, tutto preso dalla visione della partita della nazionale di calcio, neanche capisce ciò che gli succede intorno e alla moglie che gli sta confessando di essersi innamorata di un altro dice “va bene, ora che l’hai detto puoi andare”. Manca solo il rutto libero.
Caro Presidente
Ill. mo Presidente della Repubblica, On. le Giorgio Napolitano,
mi chiamo Domenico Forgione, sono dottore di ricerca in Storia dell’Europa mediterranea dal 2004 (titolo conseguito presso l’Università di Messina) e sono iscritto all’albo regionale dei giornalisti per la regione Calabria (elenco pubblicisti). Per sei anni ho lavorato come corrispondente locale de “Il Quotidiano della Calabria”, mentre continuo tutt’ora a fare parte del comitato di redazione della rivista di studi internazionali “Grotius” (edita dall’Università di Messina) e del comitato scientifico della rivista di studi sull’emigrazione “Neos” (edita dalla regione Sicilia). Sono stato anche negli Stati Uniti (2002), al seguito di una delegazione di studiosi che ha condotto una ricerca sugli italoamericani di terza generazione. Nel corso degli anni ho pubblicato tre monografie e diversi saggi di storia contemporanea. Seguo con passione gli avvenimenti politici e di attualità, tanto da utilizzare un blog personale (www.forgionedomenic.blogspot.com) per esporre il mio modesto pensiero su ciò che accade nella nostra società. Con soddisfazione sottolineo che molti di questi articoli sono stati pubblicati su diversi quotidiani locali (Calabria Ora, Il Quotidiano della Calabria).
Si sta chiedendo dove sta il problema? Il problema sta proprio in queste competenze, in questa mia attitudine allo studio e alla riflessione che non hanno alcuna utilità dal punto di vista materiale. La mia carriera universitaria si è praticamente arenata. I miei genitori non sono professori universitari, ma onesti e orgogliosi cittadini che hanno trascorso molti anni all’estero (io stesso sono nato in Australia), che hanno soltanto la quinta elementare e che con enormi sacrifici sono riusciti a fare laureare uno dei loro tre figli. Nei giornali o comunque nel mondo dei media vi sono difficoltà non minori. Difatti, una volta conseguito il tesserino di giornalista pubblicista, nessuno ha accettato la mia proposta – che poi era anche coerente con il mio percorso formativo – di assegnarmi un ruolo diverso da quello di corrispondente locale a 5 centesimo a rigo. Per questo motivo ho preferito non collaborare più. Paradossalmente, mentre prima mi facevano scrivere soltanto di cronaca bianca, sagre e feste di paese, ora che non ho neanche quell’avvilente contratto da co.co.co., mi pubblicano articoli di approfondimento politico che prima mi erano tassativamente vietati, perché le gerarchie della redazione vanno rispettate!
A 37 anni, sono un precario che più precario non si può. Terminato il dottorato di ricerca mi sono ritrovato con un pugno di mosche in mano e con poche possibilità di fare fruttare le mie competenze, avendo investito quasi tutto in una carriera universitaria che non riesce ad avere alcuno sbocco proficuo. I miei molteplici tentativi di cercare una qualche sistemazione sbattono contro un’amara realtà: la mia età costituisce ormai un serio ostacolo, così come il fatto che non possiedo alcuna professionalità “manuale” – quella intellettuale evidentemente non serve proprio. Cerco di coltivare i miei interessi intellettuali per quanto può una persona che, con laurea, dottorato e pubblicazioni, si ritrova a fare, ogni tanto (neanche con costanza), lavori per i quali non sarebbe stato necessario alcun titolo, né scolastico, né accademico.
Ill.mo Presidente, il mio è uno sfogo come tanti altri, presumo. Ma uno Stato che non riesce a dare una possibilità ha fallito tanto quanto chi si trova nella mia condizione.
Cordiali saluti
Domenico Forgione
La prova di forza
Verrebbe da rispolverare il “rieccolo” affibbiato da Indro Montanelli ad Amintore Fanfani, l’esponente aretino della Democrazia Cristiana sei volte presidente del Consiglio, tre presidente del Senato, una sfilza di incarichi in mezzo secolo di carriera, reso celebre per la capacità di risorgere proprio quando appariva in declino e fuori dai giochi. Come la mitologica araba fenice, rinata dalle proprie ceneri dopo la morte. Da questo punto di vista, tralasciando le facili ironie sul comune aspetto “brevilineo”, la similitudine è calzante.
Appuntarsi il nome dei perfetti sconosciuti che con una piroetta magistrale hanno compiuto il salvataggio del governo può essere utile per contabilizzare il degrado morale di questa classe politica. Ma nulla più, considerati i molteplici precedenti storici. Semmai, ripropone più forte la questione della necessità di riformare l’attuale legge elettorale, per restituire al popolo il potere effettivo di scegliersi i propri rappresentanti: l’unico modo per potere così “punire” i Calearo, i Cesario, i Razzi, e gli Scilipoti di turno. Riposto nel cassetto il pallottoliere, occorre invece individuare il significato politico del voto di fiducia. La vittoria numerica di Berlusconi è incontestabile, così come sembrano decisamente mortificate le ambizioni di Fini. Ma una vittoria numerica non si trasforma necessariamente in vittoria politica. Lo si vedrà con chiarezza nei prossimi giorni, quando la Camera diventerà un campo minato per un governo senza maggioranza nelle Commissioni e che, di fatto, è “di minoranza”. Non soltanto perché la soglia dell’autosufficienza è a quota 316, ma soprattutto perché circa trenta parlamentari con incarichi nell’esecutivo raramente si fanno vedere a Montecitorio. In soldoni, ciò significa che l’approvazione di qualsiasi provvedimento legislativo sarà subordinato all’accordo con l’opposizione, che ne approfitterà per fare passare i propri emendamenti, indebolendo così di molto l’azione governativa.
Viene quindi da pensare che l’obiettivo reale della prova di forza voluta da Berlusconi non fosse il proseguimento di questa esperienza governativa, bensì la riaffermazione della propria leadership, per tenere il mazzo, distribuire le carte e non essere fatto fuori da una congiura di palazzo. Dalla posizione di forza acquisita, Berlusconi può ora condurre il gioco indirizzandolo verso le sole due ipotesi per lui accettabili: una crisi pilotata che conduca al suo reincarico e all’allargamento della maggioranza; in alternativa, le elezioni anticipate. Eppure, nonostante l’affermazione muscolare del premier, il ciclo storico e politico iniziato nel 1994 può ritenersi concluso. L’immagine che ci viene consegnata è quella di un leader barricato dentro il bunker, con a fianco il solo Bossi nel doppio ruolo di protettore e ispiratore, mentre all’esterno il paese “reale” non corrisponde più alle foto idilliache dei tanti opuscoli di propaganda giunti in questi anni nelle case degli Italiani. Come è stato da più parti osservato, quella di Berlusconi rischia di rivelarsi un’effimera vittoria di Pirro.







