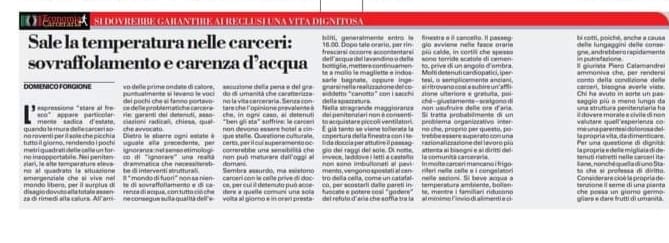C’è voluta la commissione ispettiva del Dap per accertare ciò che sapevano tutti, o almeno tutti quelli che – come ha sottolineato “Il Dubbio” – hanno un minimo di conoscenza della realtà carceraria: dietro le rivolte di marzo 2020 non c’è stata nessuna regia della criminalità organizzata. Non poteva esserci per un semplice motivo, ben noto – ripeto – a chi conosce le dinamiche interne di un carcere. I detenuti dell’Alta sicurezza (il circuito nel quale vengono ristretti condannati al 416 bis, nonché gli imputati in attesa di giudizio per lo stesso reato) hanno una prospettiva detentiva molto lunga, per cui hanno tutto l’interesse a “farsi la galera”. Sono consapevoli che eventuali inconvenienti di “ordine pubblico” provocherebbero ritorsioni che andrebbero a colpire la qualità della loro vita: dispetti più o meno incresciosi e snervanti, chiusura delle celle durante il giorno (laddove è concessa), sospensione della “socialità” e di altre attività che in qualche modo alleggeriscono il peso di giornate sempre uguali. Può sembrare paradossale, ma i detenuti dell’Alta sicurezza sono quelli che danno meno problemi all’amministrazione penitenziaria. Chi deve trascorrere dietro le sbarre 10, 20 o più anni ha tutto l’interesse a farlo nel “migliore” modo possibile. Una spicciola questione di tornaconto personale.
D’altronde, sarebbe stato sufficiente verificare i singoli episodi. Su una ventina di casi, soltanto nel carcere di Melfi la protesta interessò il circuito dell’Alta sicurezza e i protagonisti non ebbero certo alcun trattamento di favore: qualche testa spaccata dai colpi di manganello arrivò anche a Palmi nei giorni successivi.
Tranne che in circoli mediatici ristretti, l’argomento carcere sconta sempre sentimenti di indifferenza o, peggio, di ignoranza. La verità era emersa subito, ma non era quella giusta, quella che poteva avere presa nell’opinione pubblica. Ad innescare le rivolte erano state la paura per la pandemia, in una fase in cui ancora non si aveva la chiara percezione di ciò che stava accadendo, e – soprattutto – la sospensione dei colloqui in presenza con i familiari. La successiva introduzione delle videochiamate, da questo punto di vista, è stata una misura provvidenziale.
Indubbiamente di forte suggestione era però l’ipotesi di rivolte orchestrate dalla criminalità organizzata, con annesso corollario di improbabili “papelli”, veicolata dai passacarte delle Procure e dall’antimafia da salotto. «Se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi vera», ammoniva George Orwell nel capolavoro “1984”. Per cui, tutti a ruota della panzana, ministro Bonafede in testa.
Il cattivo – che esiste – è funzionale all’esercizio del potere. Senza scomodare studi autorevoli, ce lo ricorda la maschera creata da Antonio Albanese, il Ministro della Paura: «Senza la paura non si vive. Una società senza paura è come una casa senza fondamenta. Io trasformo la paura in ordine, e l’ordine è il cardine di ogni società rispettabile».
E chi se frega se i “cattivi” sono spesso in attesa di giudizio (quindi costituzionalmente ancora “buoni”), se i Comuni vengono sciolti con la formuletta imbevuta di pregiudizio “più probabile che non”, se gli imprenditori vengono ridotti al lastrico in via preventiva.
Di questo dovrebbe discutere una classe politica inerte nell’azione di concreto contrasto alla criminalità organizzata, la cui sconfitta necessita di servizi pubblici garantiti, di sviluppo e di lavoro nelle aree economicamente e socialmente depresse del Paese. Un sentiero accidentato, che si preferisce aggirare con gli arresti di massa e le misure di prevenzione, in barba alle più elementari garanzie costituzionali. Un percorso sbrigativo e rassicurante per l’opinione pubblica, ansiosa di vedere volare per aria le teste dell’Idra di Lerna. Che puntualmente ricrescono.
*Pubblicato su “Il Dubbio” (27 agosto 2022)