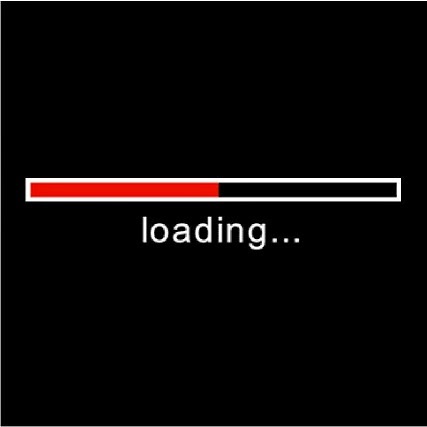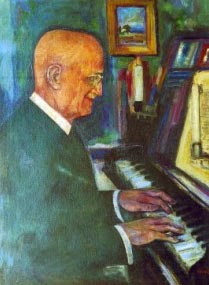Un paio di considerazioni – mi auguro – non banali sul dato della diserzione dalle urne, costantemente in crescita e confermato anche in questa tornata elettorale.
Votare nella sola giornata di domenica non aiuta. Ragioni di spending review, si motiva. Ma a forza di tagliare anche la possibilità di esercitare i propri diritti, alla fine resterà ben poco.
Disaffezione degli elettori, sempre più delusi dalla politica, ormai rassegnati al declino che comunque fa il suo corso, nonostante i politici. O forse proprio per causa loro. Può darsi.
Rabbia generalizzata contro tutto ciò che “puzza” di casta, privilegi, furberie, arricchimento personale a discapito del bene comune. Gli esempi non mancano. Se possibilità di salvezza può esistere, si conclude, è fatica sprecata cercarla in soggetti che si scannano per una poltrona. I canali da attivare sono altri, fuori dalla politica, nella strada e nell’impegno quotidiano per un mondo migliore.
Non è semplice contestare questo genere di considerazioni. Aggiungerei anche un altro elemento, non trascurabile: il disastro del Movimento Cinque Stelle, la formazione di Grillo e Casaleggio che era riuscita a intercettare lo scontento verso la classe politica dandogli “dignità” istituzionale, in forme spesso rozze e populiste, ma che ha finito per gettare nel cassonetto dei rifiuti il biglietto vincente della lotteria rivelandosi, in definitiva, forza politica inconcludente, velleitaria, autoreferenziale.
A mio avviso sono due i fattori che concorrono al dato spaventoso e preoccupante (checché ne pensi Renzi) dell’astensionismo: lo sbandamento dei partiti di destra e il fallimento del Movimento Cinque Stelle. Insomma, la “colpa” è di chi non va a votare, non di chi si reca alle urne. Ecco perché non è corretto sminuire la vittoria del centrosinistra. Chi vuole vincere deve essere in grado di avanzare una proposta politica credibile, cosa che evidentemente il centrodestra non è al momento capace di fare, intrappolato sotto le macerie del post-berlusconismo in Italia e del post-scopellitismo in Calabria, e pertanto propenso alla diserzione o al tentativo trasformistico e opportunistico di saltare sul carro del vincitore.
A maggior ragione sarebbe auspicabile il recupero dell’umiltà della militanza politica. Quella che dava, non chiedeva e neanche si aspettava. Si militava per un ideale, perché ognuno si sentiva il granello di sabbia che avrebbe inceppato la macchina del potere. I partiti sono indispensabili cinghie di trasmissione tra la società e i luoghi decisionali, strumenti di mediazione e composizione degli interessi collettivi dai quali non si può prescindere se non si vuole tornare al conflitto permanente dello stato di natura hobbesiano.
Sono stato al seggio dalle 6.45 di domenica all’alba di lunedì e conserverò l’immagine di due ottuagenari come monito da tirare fuori quando lo sconforto cercherà di prevalere sull’etica dell’impegno. Il primo fotogramma contiene un’esile figura appoggiata per tutta la durata dello spoglio alla transenna che separava il pubblico dal seggio, da dove mi lanciava occhiate di complicità ogni volta che dall’urna veniva estratta una preferenza per il nostro candidato. Il secondo, il passo lentissimo e sofferto di un compagno storico che ha impiegato 45 minuti per scendere dalla macchina, percorrere con l’aiuto di una stampella il lungo corridoio che portava al seggio, votare e fare il tragitto di ritorno.
Anche per loro occorre andare a votare, sempre. Perché c’è stata una notte buia in cui i nostri nonni non hanno potuto godere di questo e di molti altri diritti.