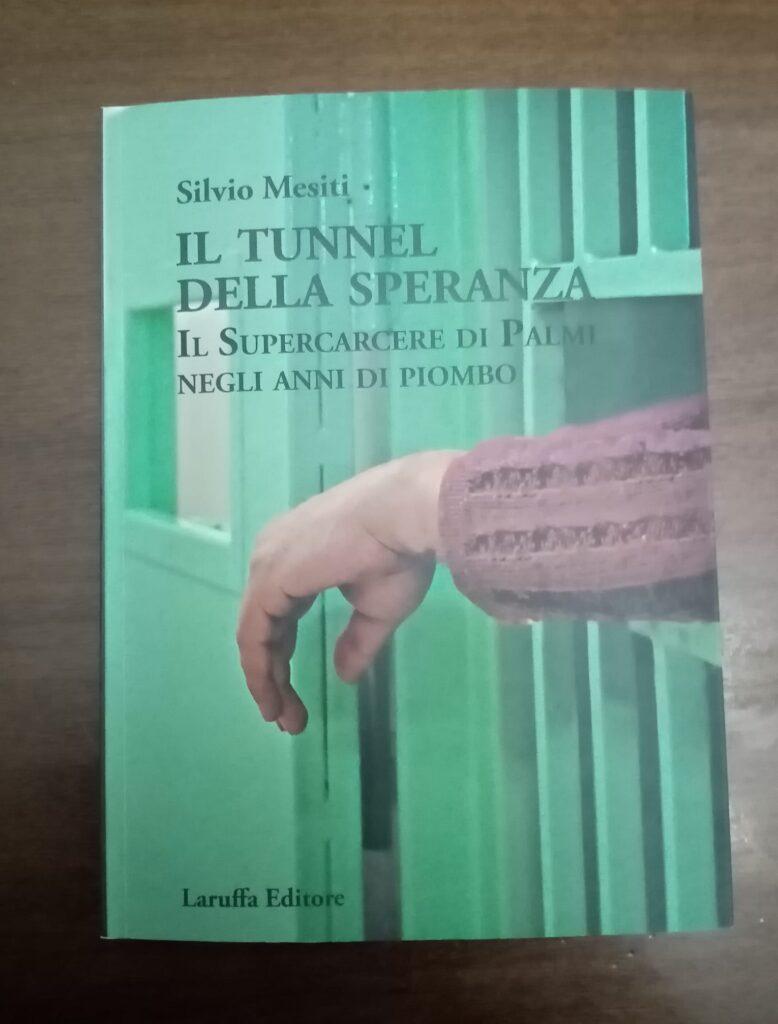Costretti in tre metri per quattro sentivamo ancora più nostre quelle parole sul Covid pronunciate dal Papa in una piazza San Pietro deserta
Nella sezione c’era un silenzio irreale. L’orologio in mezzo al corridoio segnava le 14:50. Come sempre. Chissà da quanti anni. Il tempo in carcere non esiste, che le lancette stiano ferme o si spostino sul quadrante non fa differenza. È un tempo sospeso tra una battitura e l’altra. Dai camerotti e dai cubicoli arrivava in stereofonia la telecronaca di ciò che stava succedendo in piazza San Pietro. I nostri occhi erano tutti incollati in alto, sopra il cancello serrato, fissi sul teleschermo.
Un uomo vestito di bianco attraversava la piazza deserta, sotto la pioggia, prima di fermarsi sotto un crocifisso: «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda». Parlava del Covid, ma costretti in tre metri per quattro sentivamo ancora più nostre quelle parole. Dalla rete a maglia fittissima delle finestre, nelle ore diurne, anche la luce faticava ad entrare. Ci sentivamo soli, maledettamente soli.
Dal mondo di fuori arrivavano notizie frammentarie, che stentavamo a comprendere. I camion militari con le bare, l’aggiornamento quotidiano delle vittime della pandemia dai telegiornali che divoravamo. Non ci fidavamo di ciò che ci dicevano da casa. I colloqui erano stati sospesi: restavano le lettere, le telefonate e poi, finalmente, l’introduzione delle videochiamate. L’unico lascito positivo di quella terribile catastrofe sanitaria.
Giungevano notizie sui distanziamenti, sulle autorizzazioni per uscire di casa per la spesa, sul controllo poliziesco fino a davanti l’uscio delle porte, sugli inseguimenti, le multe, le denunce. Non capivamo. Paradossalmente, tutte queste precauzioni ci erano state risparmiate. Carcere e distanziamento sono due sostantivi che non possono stare nella stessa frase. Nelle celle, nel cortile: impossibile. Mascherine, neanche a parlarne. Almeno all’inizio. Ma neanche dopo, tranne quando si doveva accedere all’infermeria o alla matricola.
Gli ultimi possono anche morire, non fanno rumore. Se così non fosse, i nostri governanti dovrebbero impazzire per i suicidi che si registrano dietro le sbarre. E agli ultimi pensava Papa Francesco. Nel disorientamento generale, lo sentivamo vicino. Avvertivamo la potenza della preghiera, che non chiede il miracolo, bensì la concessione della forza necessaria per affrontare la burrasca. Ognuno la propria. Ci nutrivamo delle sue parole di speranza e della sua compagnia ogni mattina alle sette, quando appariva sui teleschermi dalla cappella di Santa Marta. Molti di noi appresero allora che visitare i carcerati era una delle sette opere di misericordia corporale.
Papa Francesco veniva a farci visita tutti i giorni. Nel carcere di Palmi suppliva l’assenza forzata di don Silvio, che fino ad allora era stata la nostra ancora di salvezza. Con le sue parole di conforto, lo sguardo di comprensione, l’indignazione per le troppe ingiustizie che da cappellano avvertiva come conficcate nelle sue carni.
In uno degli ultimi incontri prima della cancellazione definitiva di ogni visita, gli avevo proposto di organizzare una via crucis nel cortile. In carcere non mancano i poveri cristi e, fortunatamente, neanche i cirenei compassionevoli, compagni che aiutano l’altro a sorreggere la croce con un gesto di umanità o con una parola di incoraggiamento.
Ovviamente, non se ne fece niente. Riuscì però a fare una sortita il giorno di Pasqua, ad affacciarsi dalla porta sul cortile per un saluto, a fare avere a ciascun detenuto un bocconcino con la crema. Ci restava però Papa Francesco. Il rappresentante di una Chiesa che ciclicamente e inutilmente chiede un gesto di clemenza, denuncia la barbarie del carcere, invita alla compassione e alla carità.
La mia, la nostra, tutte le solitudini del mondo si condensavano in una macchia bianca raccolta in preghiera sotto la croce. Ci sentivamo un po’ meno soli.