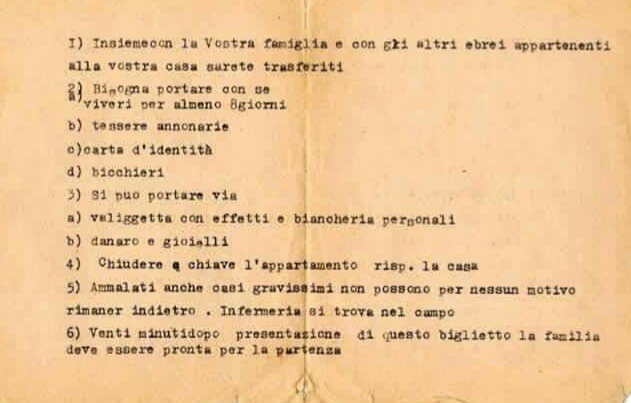“Ho scelto la vita” è il titolo dell’ultima testimonianza pubblica sulla Shoah
della senatrice Liliana Segre, condivisa il 9 ottobre 2020 nel borgo di Rondine
(Arezzo). Una scelta che le consentì di sopravvivere all’orrore di Auschwitz e di trasformare la marcia della morte in
marcia della vita: camminando “una gamba davanti all’altra, con i piedi
piagati, mentre chi cadeva veniva finito con una fucilata in testa”; brucando nei
letamai alla ricerca di qualcosa da mangiare; cibandosi con la carne cruda di
un cavallo morto, strappata con le unghie e con i denti; succhiando foglie.
Come fu possibile tutto questo? Liliana Segre lo spiega con una sola parola:
indifferenza. Dodici lettere che lei stessa ha fatto incidere a caratteri
cubitali all’ingresso del Memoriale della Shoah di Milano, realizzato nel
binario 21 della Stazione Centrale, da dove partivano i carri bestiame pieni di
ebrei destinati ai campi di concentramento: «Se pensi che una cosa non ti
riguardi e ti volti dall’altra parte, è lì che inizia l’orrore».
Furono in tanti, in Italia, a girarsi dall’altra parte. Ed è comodo, per la coscienza
collettiva della nazione, attribuirne la responsabilità in via esclusiva al
fascismo e non, piuttosto, ad un humus culturale razzista, presente nella
società italiana e capace di produrre frutti velenosi ancora oggi. Il “Manifesto
degli scienziati razzisti”, la “Dichiarazione sulla razza” del Gran consiglio
del fascismo (“È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti”),
l’esclusione
degli ebrei dalle scuole pubbliche e dallo svolgimento di determinate
professioni (pubblica amministrazione, banche, assicurazioni, notariato,
giornalismo), la negazione dei diritti politici e civili, il divieto di
matrimonio tra cittadini italiani di razza diversa furono atti e provvedimenti
che ebbero largo consenso, così come lo stesso regime fascista fino al 10
giugno 1940. Erano italiani coloro che segnalavano alle autorità, per pochi
soldi, il vicino di casa ebreo. Non dimentichiamolo.
«La memoria – scrive Ferruccio De Bortoli nella prefazione al libro – è un vaccino
prezioso. Ci aiuta a combattere con intelligenza e moderazione i miasmi del
totalitarismo che una società conserva, nonostante tutto, nel suo inconscio,
nel retrobottega della sua storia collettiva, familiare, personale».
Auschwitz – scrisse Primo Levi – è “la mancanza di parole per esprimere questa offesa, la
demolizione di un uomo”. Ed è il ricordo di Liliana, ragazzina tredicenne alla
quale viene semplicemente detto di dimenticare il proprio nome, perché da quel
momento sarebbe stata soltanto un numerino tatuato sul braccio. Nell’istante in
cui si diventa una cifra riportata sopra un registro dell’ufficio matricola inizia,
sempre, l’opera sistematica di annullamento della dignità dell’uomo.
Per Liliana Segre, scegliere la vita significò allora «sognare di essere fuori di
lì, il rumore di un bambino che gioca, un gattino, un prato verde, una
qualsiasi cosa bella». Scegliere la vita, oggi, significa fare opera di memoria
ed assumere collettivamente la funzione delle pietre d’inciampo che in molte
città europee ricordano le vittime del nazismo.