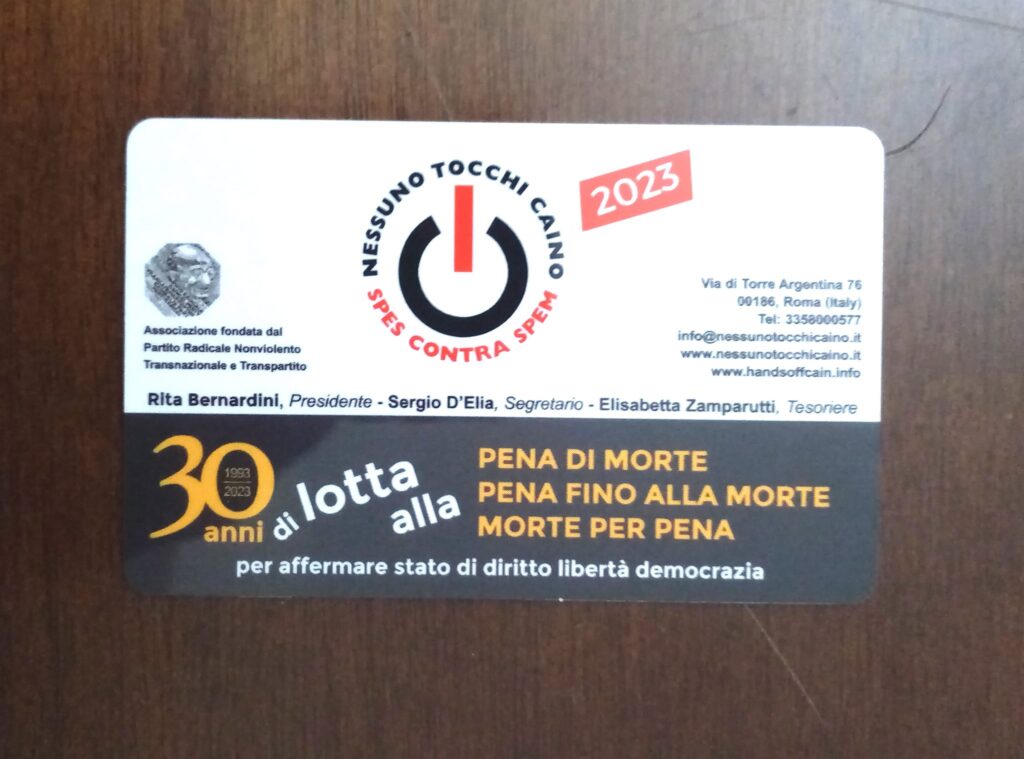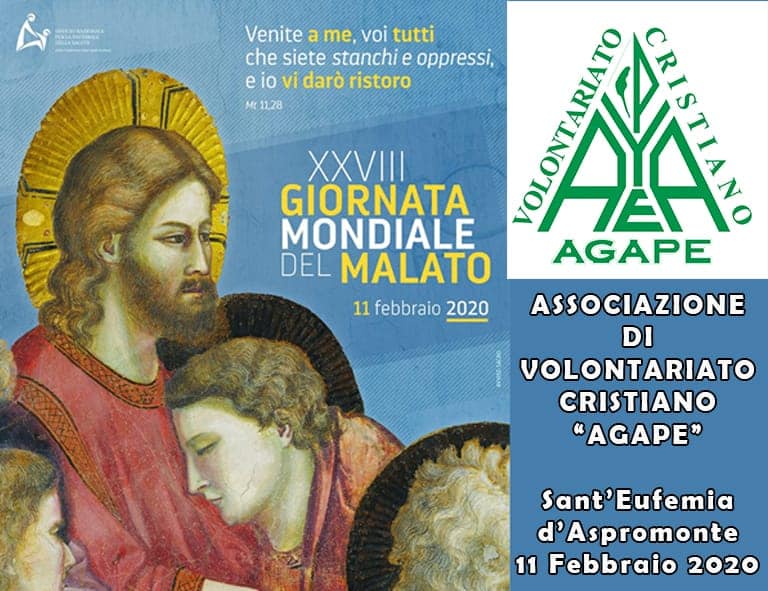Ormai dovremmo essere abituati a vederlo in televisione, in occasione delle importanti funzioni che si svolgono nel Vaticano, tenore tra le voci che compongono la “Cappella musicale pontificia sistina”. Ne fa parte da venticinque anni. Eppure ogni volta è un’emozione che si rinnova, per quel sentimento di orgoglio e di ammirazione che gli eufemiesi provano vedendo che un figlio di questa terra è stato capace di raggiungere vette professionali di assoluto rilievo.
Antonello Bille, cinquantenne cresciuto nel “Chjanu du Pettu”, a due passi dalla chiesa parrocchiale di Sant’Eufemia, che ha inciso profondamente sul ragazzo che era e sull’uomo che è diventato, ne ha fatta di strada. Anche se non ha mai reciso il legame con il paese di origine, dove torna appena ne ha la possibilità, quasi sempre ogni 16 settembre per la festa patronale, che coincide anche con la data del suo compleanno. Di questo affetto si nutre, lo custodisce nel cuore come un dono prezioso: «Chi come me va via, ha sempre il timore di venire dimenticato. Provo molto piacere quando apprendo che i miei compaesani sono orgogliosi di me e della mia attività».
È stato toccante ascoltarlo in occasione della recente Via Crucis, particolarmente intensa a causa della presenza/assenza del Pontefice, che non c’era ma il cui spirito e le cui parole hanno riecheggiato lungo il percorso dal Colosseo al Tempio di Venere sul Palatino. Poi la morte di Papa Francesco, il funerale, la consapevolezza dell’importanza del momento storico e l’emozione provata quando il feretro ha fatto il suo ingresso nella chiesa di Santa Maria Maggiore, accolta dai canti eseguiti dalla Cappella musicale: tra i cantori, Antonello Bille.
Di questo e di molto altro abbiamo parlato nel corso di una conversazione sviluppata sul filo dei ricordi, un andare per poi ritornare al punto di partenza, al luogo dove tutto ha avuto inizio: Sant’Eufemia d’Aspromonte.
Quando hai scoperto di avere questo dono e come hai iniziato?
Ho scoperto di avere questo dono un po’ tardi. Ho frequentato il liceo artistico “Mattia Preti” di Reggio Calabria e, in quegli anni, la musica e il canto erano lontani dai miei progetti di vita. In paese ho però iniziato a collaborare con il coro polifonico parrocchiale “Cosma Passalacqua”, allora diretto dal carissimo amico M° Raffaele Federico: ricordo quando ci svegliavamo alle 5:00 per la novena di Natale. Compresi che avevo delle qualità e il successivo ingresso nel conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio confermò quella sensazione. Raffaele Federico è stato per me un grande supporto, con le sue parole di incoraggiamento. Altra figura importante è stata il M° Mons. Giorgio Costantino, docente del conservatorio in esercitazione corali e direttore del coro “Laudamus” di Reggio Calabria, nel quale entrai dopo circa un anno: mi ha sempre seguito con affetto ed è stato fondamentale per la mia formazione professionale. Al conservatorio “Cilea” ho avuto maestri eccellenti, che non solo mi insegnavano la musica, ma mi sollecitavano a “crederci” perché il mondo del canto un giorno mi avrebbe dato il pane. Infine, il mio caro Maestro di canto Antonio Bevacqua, di Messina, il quale ha fatto un grande lavoro sotto il profilo tecnico. Non dimenticherò mai le traversate a bordo della “Caronte” per recarmi alle sue lezioni.
Quando sei entrato nel Coro vaticano?
Nell’aprile del 1999, mentre ero ancora allievo del conservatorio, il M° Mons. Giorgio Costantino mi informò che il Maestro della “Cappella musicale pontificia sistina”, all’epoca Mons. Giuseppe Liberto, cercava nuovi tenori. Mi presentai e sostenni l’audizione davanti a lui, al “Magister Puerorum” don Marcos Pavan (oggi Maestro direttore della Cappella), al segretario e al decano dei cantori pontifici. Nel frattempo conseguivo il Diploma in canto con lode e menzione d’onore. Il 14 settembre fui convocato ufficialmente da Mons. Giuseppe Liberto ed entrai così nel coro più antico del mondo e coro personale del Papa.
Da quanti cantori è composto il Coro, quali sono le sue attività e come si svolge la tua giornata?
Attualmente il Coro, che in genere svolge il suo servizio liturgico nella Basilica di San Pietro, è composto da 24 Cantori adulti suddivisi in tenori I e II, baritoni e bassi, e da circa 30 Cantori fanciulli (i “Pueri Cantores”, le voci bianche che secondo un’antica tradizione sostituiscono le voci femminili, suddivise in contralti e soprani). Normalmente siamo impegnati con le prove per le celebrazioni papali e i concerti, dalle tre alle quattro ore al giorno. La Cappella musicale pontificia interviene solo in presenza del Papa, anche per funzioni private nella cappella del Santo Padre oppure in altre cappelle che sono all’interno del palazzo apostolico, con il segretario di Stato. Al di fuori dal contesto delle cerimonie liturgiche svolge inoltre l’attività concertistica, sia in Italia che all’estero.
Ci sono avvenimenti che ricordi con particolare emozione?
Tantissimi, in particolare quelli legati agli anni del pontificato di Giovanni Paolo II. Su tutti, l’apertura della Porta Santa nel Grande Giubileo del 2000 e la morte di Karol Wojtyla. Nel primo caso, ero arrivato a Roma da appena tre mesi: per me era tutto nuovo, immenso, vibrante. Mi sentivo parte della Storia mentre si stava svolgendo. Dopo il Santo Padre, toccò alla Cappella musicale attraversare la Porta Santa. Ho provato un’emozione indescrivibile, amplificata dalla voce tremante di Giovanni Paolo II: un fuoco dentro il cuore che non va mai via. La sua morte diede la sensazione che il mondo si fosse fermato, che la terra avesse smesso di girare. Dalle cose più importanti fino a quelle più banali, come fare la spesa. Il silenzio che si percepiva a Roma era impressionante, solenne, intimo. E poi il funerale, con quel vento che giocava con le casule dei cardinali e, sulla bara, sfogliava le pagine del Vangelo. Ma ho provato emozione anche nei passaggi più significativi di questi ultimi 25 anni: l’elezione di Benedetto XVI e l’11 febbraio 2013, quando nella Sala Clementina pronunciò la formula della rinuncia al soglio pontificio; infine l’elezione di Papa Francesco, che per la verità nessuno nel Vaticano si aspettava.
Come hai vissuto la morte di Papa Francesco? Cosa hai provato quando la bara con il Santo Padre ha fatto ingresso nella chiesa e come ti sei sentito nel momento in cui cantavi per lui?
Sono stato presente alla constatazione di morte, poiché il protocollo del cerimoniale prevede che siano presenti, oltre al medico personale del Papa che legge le cause del decesso, tutta la famiglia pontificia, della quale fa parte anche la Cappella musicale. Poi, mercoledì 23 aprile, nella Basilica di San Pietro per la traslazione. Arrivava il momento di far vedere al mondo per l’ultima volta le sue spoglie mortali. Il cerimoniale prevede che i “sediari” portino il Santo Padre nella bara scoperta. Il momento è solenne e scandito dal camminare lento e ordinato della processione. Una situazione che io avevo già vissuto con i due precedenti Papi. Ma è come se fosse sempre la prima volta. Sono sensazioni indescrivibili, dal fortissimo impatto emotivo. Anche perché ti rendi conto che fai parte di tutto quello che sta accadendo, non sei soltanto uno spettatore. Le mani tremano e si ha paura di poter sbagliare mentre si canta. È difficile gestire l’equilibrio interiore, perché l’emozione è fortissima. Non rimane altro da fare che pregare, nel mio caso cantando. Abbiamo eseguito alcuni salmi in gregoriano, in latino a una voce, e le antifone per i defunti: “Requiem aeternam”, “Sitivit anima mea” e altre.
Hai qualche ricordo personale di Papa Francesco?
In particolare due. Nel corso di una messa celebrata nella cappella privata per i suoi cinquant’anni di sacerdozio, ebbi un incontro molto breve: il tempo di stringergli la mano, poiché nella sua grande umiltà non voleva che gli fosse baciata, di chiedergli come stesse e di ringraziarlo per la sua presenza. In occasione dei suoi ottant’anni, ebbi invece modo di soffermarmi di più con lui. Gli chiesi una preghiera per una persona a me cara: mi domandò il nome di questa persona, quindi mi strinse forte la mano e mi disse di stare tranquillo. La sua preghiera fu esaudita.
Quanto è forte il tuo legame con Sant’Eufemia?
Tantissimo, nonostante gli anni trascorsi fuori per gli studi e per il lavoro. Sono cresciuto nel rione “Petto”, a pochi metri dall’ingresso laterale della chiesa di Sant’Eufemia, dove c’erano i locali dell’Azione Cattolica”: un punto di ritrovo per me e per tanti altri ragazzi con i quali ho condiviso momenti di pace, serenità, spensieratezza e tante risate. Una sorta di porta magica che ci teneva uniti. Sant’Eufemia sta sulla prima riga del mio curriculum artistico, ne vado fiero. Con le sue strade, il pane di “Tita”, le fontane della “Pirina” e della “Nucarabella”, i posti dove da ragazzini andavamo a raccogliere l’origano, sotto il ponte della ferrovia: un luogo che ho sempre immaginato come ideale per girarci un film western. Le interminabili partite a pallone davanti alla chiesa parrocchiale, le sfide con i ragazzi degli altri quartieri, le giocate a carte sui gradini della chiesa. Sono legato intimamente alle nostre tradizioni religiose: la pietà popolare è il ponte indispensabile affinché ogni essere umano si avvicini alla casa del Signore. E poi la nostra amata Sant’Eufemia, che ancora oggi ci parla e ci protegge. Il mio rapporto con “Lei” è iniziato il giorno della mia nascita: mio padre ancora oggi si commuove raccontando che mentre “Lei” usciva dal portone della chiesa per la processione, io venivo al mondo uscendo dal grembo di mia madre. Il giorno della festa cerco sempre di essere presente, anche se ogni tanto non mi riesce. La cerco ovunque, specialmente da quando mi sono trasferito a Roma. Mi affido sempre a Lei. Quando mi distraggo, succede qualcosa che mi fa capire che “Lei” è vicino a me. Non mi sono mai sentito abbandonato, né ho perso la strada che mi conduce a “Lei”. Ricordo con commozione le feste, le “entrate” con i magnifici fuochi d’artificio, le processioni sontuose e partecipate da tutti. So che qualsiasi cosa dovesse accadere, quei momenti li porterò sempre dentro di me. Ormai, da venticinque anni, la mia vita è a Roma: ma, anche se un giorno non dovessi più tornare, per il mio paese pregherò e spererò sempre il meglio.