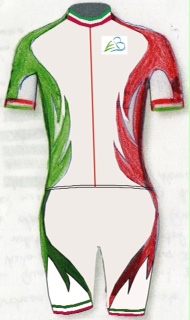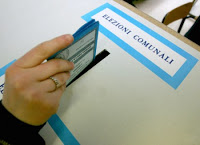La divisa somiglia a quella del campione d’Italia e la indosseranno undici nuovi campioni (con la speranza che presto diventino di più), lungo le strade della provincia. I più audaci anche oltre. È facile prevedere due fasce, una selezione già evidente nella passata stagione, quella del rodaggio per i nuovi e per coloro che non salivano su una bicicletta da corsa da tempo immemorabile, dagli anni della rivalità tra Saronni e Moser, tanto per intenderci. Campioni e gregari, come in tutte le squadre che si rispettino. I primi, serissimi negli allenamenti e attenti nell’alimentazione, macineranno chilometri su chilometri, cercando sempre di spostare in avanti l’asticella dei propri limiti. I secondi si accontenteranno di ammirare il panorama da Sant’Elia, o di attraversare i paesini toccati dalla vecchia Littorina, o di sfiorare il mare di Scilla per poi inerpicarsi sui tornanti che riportano a casa. Soprattutto, non avvertiranno alcun senso di colpa se le loro prestazioni a tavola saranno migliori di quelle sui pedali.
Affiliati alla federazione ciclistica italiana, gli “Eufemiesi Bikers” si sono dati uno statuto e un organigramma approvati all’unanimità. Presidente non poteva che essere Mimmo Fedele, volto storico del ciclismo eufemiese, già compagno di squadra di Girardengo. Vicepresidente Sarino Surace, lo “stilista” della squadra e uno dei due oriundi, insieme ad Antonio Forgione. Completano il direttivo il tesoriere Rocco Luppino, il segretario Enzo Fedele e il presidente onorario Lorenzo Genovese, la locomotiva umana. Senza nulla togliere al resto della squadra, Antonio, Rocco e Mimmo sono di un altro pianeta. Noi facciamo da contorno. Io per primo, tra l’altro preso “a prestito” dal pallone, che rimane sempre il mio unico vero amore. Il peso c’è, decisamente: come se pedalassi con lo zaino “tattico” sulle spalle. Non proprio il massimo. Gli altri “gregari” sono Cosimo Pinneri, che passa indifferentemente dal fuoristrada alla moto, allo sci, alla bici e a chissà quanti altri hobbies; Ninì Creazzo, che potrebbe avere un futuro (ma non ce l’avrà); Maurizio Luppino, che vorrebbe avere un futuro (ma non ce l’avrà); Domenico Colella, al quale di avere un futuro sulla bicicletta non frega niente.

[La primavera si avvicina, è ora di mettere a punto la bicicletta. La strada ci attende]